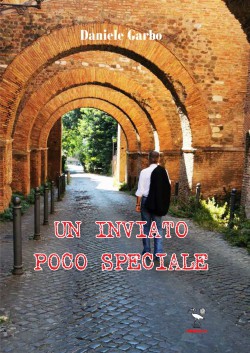Daniele Garbo
Un inviato poco speciale
Quarant’anni di giornalismo raccontati attraverso personaggi famosissimi ed episodi in gran parte inediti. L’autore apre i cassetti della sua memoria per farci conoscere un giovanissimo John McEnroe, Adriano Panatta pieno d’orgoglio, Nicola Pietrangeli in vena di confidenze, Mike Tyson respinto al ristorante, Francesco Totti timido di fronte alla sua prima intervista televisiva, Gianni Rivera ancora arrabbiato per la famosa staffetta con Mazzola, un’intervista doppia ai fratelli Inzaghi, Carlo Ancelotti dal volto umano, Fabio Capello senza peli sulla lingua, Beppe Signori pentito, Marco Tardelli scatenato, un esilarante siparietto tra Cesare Maldini e Arrigo Sacchi, Cesare Romiti in versione tifoso. Ma anche un inquietante week end a casa Gheddafi. Tutto raccontato con uno stile scorrevole e leggero che tiene il lettore incollato alla pagina.
Primo capitoloUN CALCIATORE MANCATO
“Il mio sogno è fare il calciatore professionista”. Lo scrissi alle scuole medie in un tema in classe il cui titolo era: “Cosa vorrei fare da grande”. Il professore d’italiano chiamò mia madre, preoccupato che, anziché pensare di fare il medico, l’avvocato, il notaio, l’architetto, l’idraulico, il falegname, l’insegnante o magari il giornalista, avessi espresso il desiderio di correre dietro a un pallone. Cambiai ben presto idea, non appena mi resi conto che il mio talento non era pari alla passione. Se invece ci fossi riuscito, non avrei mai scritto questo libro. Questo è il piccolo articolo che regalai qualche anno fa a un sito web dedicato al calcio dilettanti.
L’ odore dell’erba e il profumo dell’olio canforato. Sono la prime cose che mi vengono in mente quando ripenso alla mia, ormai lontanissima, esperienza nel calcio giocato. A Padova, dove sono nato, e provincia si trovano ancora molti campi in erba “vera”. Solo chi ha giocato a calcio, anche a livelli infimi come i miei, sa cosa significa l’odore dell’erba. Erba secca, erba umida, erba fradicia di pioggia. E poi l’olio canforato che nei mesi invernali ci spalmavamo (da soli, ma quale massaggiatore?) sulle gambe per scaldare i muscoli. I miei primi ricordi di un pallone risalgono ai tempi della parrocchia, all’epoca grande scuola di sport. Giocavamo in un campetto che sarà stato a occhio e croce 50 metri per 25. Due capitani (di solito i più bravi) facevano le squadre scegliendo alternativamente un giocatore. Io venivo scelto quasi sempre per ultimo, essendo il più scarso. Anzi, spesso non mi sceglievano neppure, perché ero proprio l’ultimo rimasto e dovevano accontentarsi di quello che passava il convento. Il pallone era un lontanissimo parente di quelli tecnologici e leggerissimi di oggi. Era di cuoio marrone e quando pioveva arrivava a pesare qualche chilo, al punto che risultava difficile calciare. Si giocava per due o tre ore, si finiva esausti e quando il campo era pesante per la pioggia eravamo delle maschere di fango. Quando arrivavo a casa (in parrocchia non c’erano naturalmente le docce), mia madre inorridiva, mi faceva spogliare in garage e poi mi spediva a lavarmi e disinfettarmi. Diventato un po’ più grande, mi tesserai per una squadra giovanile, il Petrarca, in Prato della Valle, all’ombra della basilica di Santa Giustina. Giocavo ala destra perché ero brevilineo (o bassotto, a seconda dei punti di vista), scattante e bravino in velocità. Ma la tecnica era quello che era, Madre Natura non era stata certo generosa con me. In una stagione misi il naso in campo per non più di dieci minuti, era la panchina il mio habitat naturale. Alla fine mi trasferii a un’altra società, vicino a casa, l’Esedra Don Bosco, proprio quella della parrocchia dove avevo tirato i primi calci. Facevamo il campionato provinciale juniores, ci allenava un signore corpulento, all’apparenza un duro, ma in realtà uno dall’animo gentile che coltivava fiori. Aveva allenato in serie C e per noi ragazzi era una sorta di mito. Ci allenavamo tre volte la settimana e giocavamo la domenica mattina alle 10. Ero sempre il primo ad arrivare all’allenamento e l’ultimo ad andarsene, nel tentativo (vano) di migliorare il mio bagaglio tecnico modestissimo. Da ala mi ero trasformato in terzino destro. Visto che di gol ne segnavo pochini, cercavo di non farli segnare agli avversari. All’inizio partivo dalla panchina e qualche volta entravo nel secondo tempo, quando c’era da difendere il risultato. Poi a un certo punto diventai titolare, non so bene se per meriti miei o per demeriti altrui (ma propendo per la seconda ipotesi) e non uscii più. Ricordo una partita in cui perdemmo di misura e l’allenatore durante l’intervallo era una furia perché la squadra era svogliata e senza determinazione. “Oggi - disse l’omone - mi vergogno di essere il vostro allenatore. Vi prenderei a calci tutti. Tranne uno: Garbo, l’unico che ci mette l’anima. Ne vorrei undici come lui”. I compagni mi guardavano strano, io andavo in giro a testa alta, orgoglioso - io, il più scarso di tutti - che il mio tecnico si fosse accorto di me. Arrossii e, non so come, trovai il coraggio per dire: “Mister, la ringrazio. Ma con 11 come me, bene che vada fa 0 a 0. Però non vince neppure una partita”. Tutti scoppiarono a ridere e si sciolsero in un applauso. Raggiungemmo la fase finale, ma non vincemmo nulla. In una delle ultime partite mi trovai a marcare il numero 11 avversario, un’ala sinistra dal fisico imponente e dalla buona tecnica. Era anche il capocannoniere del nostro girone. All’epoca non esisteva ancora la marcatura a zona, ma si marcava strettamente a uomo. Lo stopper sul centravanti, il terzino destro sulla seconda punta. Prima della partita l’allenatore mi disse: “Garbo, oggi ti affido il compito più difficile: devi seguire il numero 11 anche quando va in bagno, non devi dargli respiro, non devi farlo girare, non devi farti puntare, non devi farlo partire in progressione, altrimenti non lo prendi più. Cerca l’anticipo, visto che sei sicuramente più agile di lui, e se ti scappa mettilo giù e poi aiutalo a rialzarsi chiedendogli scusa”. Quel giorno sembrai un giocatore di calcio, disputai una partita praticamente perfetta. Il temutissimo numero 11 non toccò palla, non riuscì mai a dribblarmi, lo anticipai un sacco di volte. E tutto commettendo sì e no un paio di falli. Alla fine l’allenatore mi fece i complimenti. Fu il momento più alto della mia carriera. Una carriera chiusa senza espulsioni e con una sola ammonizione. Per proteste, io che accettavo qualsiasi decisione dell’arbitro e non protestavo proprio mai. Ma anche quella volta ero innocente. L’avversario mi prese per un braccio, mi strattonò e finimmo entrambi a terra al limite dell’area. L’arbitro mi fischiò punizione contro e mi disse: ”Numero 2, a braccetto si va solo in passeggiata”. Gli risposi che era stato lui a prendermi sotto braccio, non io. Mi ammonì per proteste. La mia carriera finì al termine della stagione, dopo un paio di partite in prima squadra nel campionato di Seconda Categoria. Mi ero iscritto all’università e lo studio era diventato la mia priorità. O almeno cosi dicevo. Ma mentivo a me stesso. Se non avessi avuto due ferri da stiro al posto dei piedi, avrei continuato, eccome. Ma io e il calcio non eravamo proprio fatti l’uno per l’altro.
Specifiche
- Pagine: 168
- Anno Pubblicazione: 2020
- Formato: 150*210
- Isbn: 978-88-31243-27-8
- Prezzo copertina: 15€