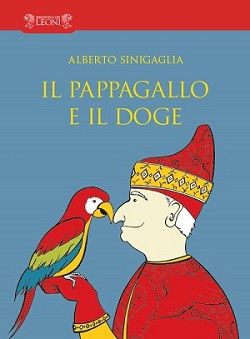ALBERTO SINIGAGLIA
IL PAPPAGALLO E IL DOGE
Storie di una vita, attraversata e determinata dalla lunga professione di giornalista: incontri, amicizie, esperienze straordinarie in giro per l’Italia tra Venezia, la città natale, e Torino, sede della “Stampa”, passando per Roma e Milano e tanti altri luoghi. Alberto Sinigaglia ha un talento innato del raccontare e ciascuna delle sue storie ha la ricchezza e la densità di un romanzo. La cronaca delle occasioni e dei giorni si fa racconto d’avventura, i caratteri dei personaggi (che si tratti di Ugo Pratt, Mario Soldati, Aldo Palazzeschi, Enzo Biagi, Massimo Mila o qualsiasi altro) diventano parte della trama stessa e ne guadagna la narrazione che ci trascina inavvertitamente dalla realtà dentro la leggenda. Il libro della memoria si trasforma in affondo narrativo che, dietro alle circostanze quotidiane, scopra la vita piena di significati, di prospettive, di veri e propri prodigi. La lievità, l’assenza di enfasi, la delicata ironia, la sensibilità visiva si fondono in una naturalezza che è il maschio di uno stile felice e coinvolgente.
Il Premio di Microeditoria Italiana 2020 ha assegnato il Marchio di Qualità a Il pappagallo e il Doge.
Primo capitoloNebbia sulla Laguna. Sera freddina a Malamocco. Appuntamento da Scarso, la trattoria con pergolato tra i ritrovi preferiti della nostra banda di transfughi, in quegli Anni Settanta, capeggiata da due narratori già noti: Hugo Pratt e Carlo Della Corte. Ritorniamo a Venezia il fine settimana, quando è possibile. Negli ultimi tempi possibile non
è stato. E questo, oltre al clima, ci rende più contenti e frettolosi nel raggiungere la saletta che già odora, lieve, di buon pesce. C’è un motivo in più: durante la cena consegneremo il premio letterario «Gransio poro» a Mario Soldati. Con lui, torinese giramondo, case a Milano e a Tellaro, vogliamo sfatare il sospetto di campanilismo che potremmo aver suscitato premiando, uno dopo l’altro, gli autori veneziani Alberto Ongaro e Nantas Salvalaggio. Nessuno di noi può immaginare che stasera ci capiterà qualcosa di straordinario: parteciperemo alla nascita di un romanzo. Manca Pratt, che si vedrà domani. Soldati ha telefonato d’essere in ritardo. Parte subito un giro di «ombre» di aperitivo e di consolazione. Sorpresa: non facciamo in tempo ad alzare il bicchiere che irrompe Mario, con una signora – avrà la metà dei suoi anni – e una giacca di chachemire dai toni azzurri, morbidissima, nota a chi l’abbia incontrato da poco a Torino. Passeggiava con Einaudi sotto i portici di piazza San Carlo. Sfiorando le vetrine di un negozio di abbigliamento l’avevano folgorato il taglio, il colore e il prezzo di quella giacca: 850 mila lire (un giornalista praticante che era con loro percepiva 180 mila lire il mese). «Giulio, guarda che meraviglia!», gridò indicandogli l’oggetto del desiderio. L’editore, avanti di qualche passo, si fermò. Senza girarsi del tutto alzò regalmente il braccio destro, schioccò le dita: «Nico... e compragliela!», fece al giovane addetto stampa che sulla guida del telefono figurava Orengo marchese Nicola e sarebbe presto entrato nella rinomata scuderia degli autori.
Finiti i saluti? A tavola, allora! Quando si affaccia Gino Scarso con altre due «ombre» per gli ospiti, Soldati vuol sapere subito da lui se il vino sia vero Prosecco di Valdobbiadene e delle sue colline bagnate dal Piave. Che cosa producano le superstiti vigne dell’isola tra il Lido e gli Alberoni. Se ve ne siano altre a Sant’Erasmo e nell’estuario veneziano. E se la motonave per Chioggia continui a far tappa lì, al pontile che le onde lagunari cullano a ottanta metri dal locale. Sbarcando da quel battello – racconta – era capitato da Scarso per la prima volta e per caso anni addietro.
Posato il bicchiere dopo un breve sorso, lo scrittore estrae un taccuino dalla tasca sinistra dell’adorata giacca. Prende appunti. Bombarda di domande gli amici. Fortuna che il sapiente Scarso aveva già dato ordini in cucina, dalla quale viene il bendidio: un superbo baccalà mantecato, canocie, latte di seppia, magistrali sarde in saòr, fumanti vongole saltate, crudi commoventi tartufi di mare, capesante perfettamente gratinate, l’inebriante risotto di pesce. Poi una sontuosa grigliata adriatica con tanto di anguilla del Polesine, che Mario accoglie con un urletto di meraviglia.
Invece di rallentare il ritmo della conversazione, i vini e i cibi le donano un’ilare frenesia. Tra Mario e i commensali incalza un pingpong d’idee, informazioni, aneddoti: sul rosso
Raboso che sa accordarsi bene con il pesce, sul mangiare e sull’allegria naturalmente, e sul Lido, su Venezia, sul ponte della Paglia, piazza San Marco e i riti del Caffè Florian, sui frequentatori del Casinò, sulla Biennale, su certi artisti d’oggi, tirati in ballo e un po’ sbertucciati da Giuseppe Mazzariol, baffuto tribuno di storia dell’arte, che intreccia un saporoso duetto con Soldati. L’attore Lino Toffolo contende loro la scena e la risata, così bene che l’ironico Della Corte, il giornalista Arrigo Bongiorno, la simpatica riservata dama che accompagna lo scrittore e io ci godiamo lo spettacolo, limitandoci al controcanto minimo indispensabile per non disturbare la recita e non perderne nulla.
All’improvviso Mario, come se la sua mente si staccasse di lì per pensare a tutt’altro, mi stupisce chiedendomi di Milano, dove ci siamo conosciuti alla Mondadori (nell’ufficio di Arnoldo, il fondatore, con Vittorio Sereni e Domenico Porzio) e di Torino, dove ci siamo ritrovati alla «Stampa»: vuol verificare nomi di comuni conoscenti, nomi di quartieri, di luoghi. Mi stupisce di più che continui a prendere appunti, sebbene si sia cambiato discorso. E che, tra le labbra il bocchino col mezzo toscano spento, un ciuffetto di capelli grigi sulla fronte, sembri scrivere frasi intere.
Scrive, infatti: «Una strana, inspiegabile allegria era nell’aria ventilata del Lido, quella fine di una mattina di giugno, quando approdai col vaporetto». Comincia lì, su quel tavolo, un romanzo. Forse ha già in testa il titolo, «L’Incendio», con il quale uscirà da Mondadori nel maggio dell’anno dopo, 1981. Con la mente soffia via la nebbia, cambia stagione. Sostituirà ai commensali i suoi personaggi, ma collocherà tra loro Gino Scarso: «Arriva di corsa, e non per chiederci che cosa vogliamo mangiare né, tanto peggio, col menù, ma già portando tra le braccia seminude la prima pietanza, un’enorme saltata di vongole».
Riecco la scena di quella sera, in presa diretta: «Attraverso le volute del fumo fragrante e pungente della salsa di erbe che si innalzava dalla zuppiera ci sorrideva il roseo, biondo, riccioluto giovane oste. Ah! la soave musicale sonorità delle conchiglie rimestate e tra loro cozzanti mentre Scarso le scodella». Riecco il nostro vino: «E è già lì, subito, un ragazzo con le bottiglie. Stappa. Versa. Contrariamente a tutte le regole che sul pesce e sui frutti di mare lo vogliono bianco, vino rosso. Raboso veronese. Scarso lo pigia nelle vigne che sono attigue all’osteria, in un terreno ghiaioso e sabbioso, là dove l’isola di Malamocco è più stretta, tra l’argine verso il mare e la sponda verso la laguna». Riecco la Biennale, il Casinò, il ponte della Paglia, San Marco, il Caffè Florian con «un armagnac lasciato là».
Mario verrà a Torino, al giornale, con venti, trenta cartelle alla volta. O me le manderà, ingiungendo: «Devi, assolutamente devi dirmi tutto quello che non va. Soprattutto i dialetti! Controlla se faccio parlare bene in veneziano e in triestino». Allora gli ricorderò: «No, Mario, il rosso che bevemmo insieme, dopo il Prosecco, non era veronese né tantomeno del Lido, era un Raboso del Piave». Gli spiegherò che quell’«argine verso il mare» sono i celebri Murazzi costruiti dalla Serenissima. Che scriverei Laguna con la maiuscola. Allarme: «Guarda! T’è scappato un “grige” senza la i». Mi telefona anche a notte fonda – di notte Mario lavorava, talvolta aspettando l’alba – per chiedermi come rendere con la scrittura quei modi, quei suoni veneziani e triestini, presumendomi affidabile per le mie radici.
Quando mi farà leggere le bozze complete, resterò di stucco. Non c’è traccia dei suggerimenti, né delle correzioni. Vi ritrovo persino il «grige» senza la i. Ma non lo sottolineo più, non glielo dico neppure. Perché Mario, lealmente, affettuosamente mi spiega che quel filo diretto con me gli era servito per altri dettagli, particolari, sfumature, per riassaporare l’atmosfera della serata a Malamocco, e quella memoria era il motore del romanzo che stava nascendo.
Aveva tutti gli ingredienti del successo «L’Incendio», pur stampato con quel «grige» sfuggito anche ai correttori dell’editrice (agguerriti professionisti, ancora lontani dall’essere sostituiti con i fallaci correttori automatici). «È certamente un romanzo che prende dal principio alla fine», esordisce Italo Calvino nella lunga lettera con la quale risponde a Soldati, che confidenzialmente gli ha inviato il dattiloscritto.
La vicenda comincia con una storia d’amore, e di amori, che s’intreccia con attraenti misteri. Vitaliano, maturo professionista, vive un legame impossibile con la figlia di amici, milanese, giovanissima, promessa sposa di un coetaneo. Con lei viene a trascorrere l’ultimo incontro a Venezia. Per dono di nozze e d’addio, sceglie un grande quadro esposto alla Biennale: «L’Incendio». Il pittore Mucci che l’ha eseguito – colto e dissipato, geniale e avventuriero, studio a Torino, matronale amante a Bardonecchia – lo induce a comprargli tutte le tele. Gli occorrono molti soldi per un viaggio in Africa, che durerà anni. Sparisce. Si ha notizia d’una tragica fine. Vitaliano, divenuto mercante delle sue opere, ne cerca altre. Il figlio di Mucci gliene vende una che qualcuno denuncia come falsa, eppure sembra autentica: un panorama alpino nettamente di mano dell’artista, come assicura il massimo critico d’arte di Milano tra un andirivieni di giovanotti, tuttavia con un particolare che il pittore scomparso non poteva aver notato, trattandosi di una diga costruita dopo la sua partenza. O il falsario è abilissimo oppure...
Un intreccio «pieno d’interrogativi e colpi di scena», sottolinea Calvino nella lettera a Soldati. Apprezza «L’Incendio» pure «per i maggiori temi psicologici che vi sono coinvolti»: l’amicizia, «tema tuo per eccellenza»; «l’oscurità del desiderio o il brancolare delle passioni o la fragilità della carne»; il denaro con «il suo posto in mezzo ai drammi dell’anima»; e «la menzogna, la mistificazione, l’intrigo: il che rimanda alla verità (o alle verità) sotto ogni maschera». Inoltre «il tema dell’arte, che qui è nel cogliere lo spirito dei luoghi e degli ambienti: di Venezia, di Torino, dell’Africa occidentale, della Val di Susa».
Se «L’Incendio» rappresentò un anello formidabile della nostra amicizia, il comune lavoro alla «Stampa» ne aggiunse altri poderosi. Pur pronto a scrivere di tutto, su tutto, Soldati preferiva gli ampi articoli di viaggio o di memorie in Terza pagina. Perché vi esercitava simultaneamente le qualità di giornalista e di scrittore, perché li poteva programmare riservandosi tempo per i libri che aveva di continuo in cantiere e perché gli venivano pagati meglio. Attento com’era al denaro, simpaticamente, ma assai caparbiamente. Doveva esserlo, per mantenere la splendida villa sul mare a Tellaro, il rifugio che aveva trovato con la moglie Jucci Kellerman, l’attrice di cinema che aveva conosciuta grazie al suo secondo mestiere, di regista.
Difficile immaginare che un appassionato e raffinato esperto di vini potesse essere tanto amico dell’acqua. Eppure con l’acqua ebbe rapporti precoci, buoni, persino eroici: a Torino nell’autunno 1922, sedicenne, non esitò a gettarsi dai Murazzi nelle fredde acque del Po per salvare il fratello del suo amico e compagno di liceo, il futuro poeta giornalista Tino Richelmy. Ne ebbe la medaglia d’argento al Valor civile. Ovvio che, fin da piccolo, al mare andasse volentieri. Caso più unico che raro per una famiglia della borghesia torinese, i Soldati non villeggiavano in Liguria, bensì in Versilia. Vicini di ombrellone i Pincherle di Roma, con il figlio Alberto, diventato scrittore anche lui col cognome della mamma, Moravia. Ricordava: «A Viareggio io avevo tra gli undici e i quattordici anni; Moravia uno di meno... Era scontroso, un po’ triste. Ma forse ciò va attribuito al fatto che sua madre era una rompiscatole, come del resto la mia... La signora Pincherle si serviva di me. “Guarda Mario, guarda quanto è bravo!” e gli rompeva i coglioni, perché mia madre e sua madre erano due tiranne, stesso carattere, volevano tutte e due che i loro figli diventassero famosi».
Quando, nella maturità, Soldati si trovò davanti a una scelta definitiva, non scelse la Toscana, ma la Liguria. Il regista di cinema, lo scrittore, il giornalista, il pioniere televisivo
amava Torino, dov’era nato, e Roma, «Le due città» alle quali aveva dedicato un romanzo. Aveva avuto casa, editore e affetti a Milano. E aveva nel cuore l’«America primo amore», come dice un suo titolo famoso. Ma quando scoprì Tellaro, vicino a La Spezia, se ne innamorò, pensò che quello fosse il Paradiso e, «non certissimo d’essere ammesso un giorno a quello definitivo», vi si fermò. Acquistò la splendida casa a picco sul Mar Ligure, nel quale poteva tuffarsi, scesa un’impervia scaletta. Più che un rifugio, una piccola reggia, dato che – cominciando la vecchiaia a fare danni – si circondò di una corte femminile: Gina la segretaria, una cameriera, un’infermiera e, saltuari, un giardiniere e un autista. Teneva moltissimo alla «Croma» che gli aveva regalata Gianni Agnelli. Volle far sapere all’Avvocato che s’era fatta vecchia pure lei. La nuova automobile arrivò, finalmente, in giardino. Fu la penultima volta che vidi Mario felice. L’ultima sarebbe stata durante una delle visite con Sheila. Gli piaceva la sua giovinezza e il suo interesse per il cinema. Gli piaceva fare la passeggiata minima dalla villa al vicino ristorante di Miranda a braccetto con lei e con me, lasciando penzolare l’inseparabile bastone. Gli piaceva che ritornassimo da lui la sera, dopo cena, per rivedere insieme un suo film.
Un giorno tanto faticava a camminare che decidemmo di fare in auto la passeggiata minima. Ma a tavola si riprese, scherzò con Miranda, pretendendo che gli legasse al collo uno di quei tovaglioloni utili per non macchiarsi con cibi pericolosi. Aveva, d’un tratto, voglia di raccontare, lucidità, memorie e le giuste parole per dirle. Soltanto il titolo d’una canzone faticava a ricordare: la canzone che aveva cantata Jucci in un’occasione speciale. Ma se ne ricordava nettamente i versi e il motivo. Allora cantò: «Parlami d’amore Mariù, tutta la mia vita sei tu»... Cantò sommesso. La locanda non era rumorosa. Gli avventori, ammutoliti, le forchette a mezz’asta, stettero ad ascoltare il bel vecchio, gran vecchio. A cogliere quell’estremo pensiero di felicità.
Specifiche
- Pagine: 144
- Anno Pubblicazione: 2017
- Formato: 14,5 x 21
- Isbn: 9788898613922
- Prezzo copertina: 16,00