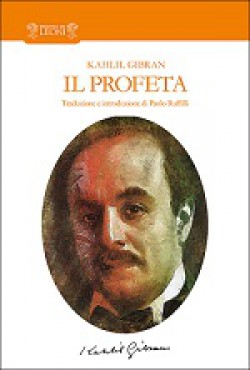KAHLIL GIBRAN
IL PROFETA
Il Profeta esce nel 1923 e procura subito vasta fama all’autore, facendolo conoscere in tutto il mondo attraverso numerose traduzioni. È il libro che più felicemente compendia le diverse anime di Gibran, fuse alla luce di quel cristianesimo di matrice maronita che sintetizza le diverse istanze culturali, orientali e occidentali, dell’autore e che fa convivere, in una sorta di eresia liberatoria, ortodossia ed eterodossia, monoteismo e panteismo. Un canto profetico nel quale, accanto alle verità della tradizione evangelica, trovano spazio credenze d’altra provenienza religiosa (islamismo, buddismo, induismo).
Traduzione e introduzione di Paolo Ruffilli
Primo capitoloIl misticismo filosofico
Il Profeta doveva essere il primo libro di una trilogia non portata a compimento e arrestatasi alla sua seconda parte, anch’essa rimasta inconclusa, Il Giardino del Profeta. Gibran ci lavorava, almeno come progetto ancora indifferenziato, fin dal tempo della sua frequentazione della Scuola della Saggezza, a Beirut. Come testimonia l’autore stesso: “Credo di non essere rimasto mai senza sentire il Profeta dentro di me, fin dal primo momento in cui ho concepito il libro laggiù sui monti del Libano. E mi pare che sia diventato così una parte decisiva di me stesso.” Il Profeta uscì nel 1923, ma ha dietro di sé più di vent’anni di lenta e stratificata elaborazione, che corrispondono alla progressiva presa di coscienza delle proprie radici, da parte del suo autore, nel parallelismo delle due anime che caratterizzano l’uomo prima ancora dello scrittore: “il me figlio dell’Oriente e il me a confronto con l’Occidente.” Cristiano maronita, coinvolto per necessità nella diaspora libanese negli Stati Uniti, Gibran, mentre recuperava consapevolezza e acquistava esperienza della cultura dei suoi padri confrontandola con “l’altro polo” del mondo americano in cui viveva, andava elaborando una sua utopica concezione eclettica capace di conciliare assunti e credi diversi. In questo senso, del resto, il Libano gli offriva molto più di un’occasione fortuita. Per quel suo essere stato, per eccellenza, territorio di incontro e di mutuo scambio tra razze, culture e religioni: crogiuolo in qualche modo privilegiato, in cui ritrovavano quasi la loro primigenia unità di partenza arabi, ebrei e cristiani. Erano, insomma, proprio la terra natale e la sua tradizione sapienziale, percorsa da un naturale empirismo sposato a forti tensioni metafisiche, che spingevano Gibran a farsi interprete di quella auspicata rigenerazione, frutto della coniugazione di Oriente e Occidente, in una chiave dell’integrazione in parte anche contestativa, dal punto di vista della “rivolta contro l’Occidente attraverso lo spirito dell’Oriente,” secondo le parole dell’autore. Gibran, comunque, era disposto fortemente a questa soluzione sincretistica anche per la sua duplice formazione, che gli faceva in fondo considerare sullo stesso piano, con la medesima adesione, le suggestioni del cristianesimo (nella versione orientaleggiante del rito maronita, che è un ramo del rito siriaco) e quelle del prediletto romanticismo europeo.
Ecco la ragione per la quale si devono richiamare, tra le fonti del Profeta, due generi di testi in parallelo. Da una parte, i libri della fede, a cominciare dalla Bibbia nella versione dei gesuiti arabi, fino al Corano e in particolare ai testi esortativi della sua sezione parenetica, oltre ai testi del sufismo. Dall’altra, i libri della cultura: Così parlò Zarathustra di Nietzsche, con la sua visione eversiva affidata a un discorso d’intonazione biblica e con il suo potente lirismo di specie profetica, i Canti di Blake, con le loro visionarie rievocazioni di storie bibliche affidate a un simbolismo fantastico e divinatorio, la Lettera sulla provvidenza di Rousseau, scritta in polemica con Voltaire in difesa del migliore dei mondi possibili, e ancora: La rivolta dell’Islam di Shelley, con la sua contaminazione liricamente risolta di misticismo e di spirito libertario, le Odi di Keats, con la loro immaginazione lussureggiante, e quelle di Wordsworth, con la loro ispirata rivalutazione della vita quotidiana, per arrivare ai trascendentalisti americani come Ralph Waldo Emerson. Senza dimenticare l’influenza di uno scrittore libanese di qualche anno più vecchio, Ameen Rihani e del suo romanzo The Book of Khalid, il primo romanzo scritto in inglese da un arabo, pubblicato tra l’altro con le illustrazioni di Gibran. La natura stessa delle fonti, dalla proiezione religiosa dell’Apocalisse a quella laica di Così parlò Zarathustra, testimonia l’esigenza di Gibran di far ricorso alla profezia per dar voce al corpo della sua utopia, nella chiave di una ispirazione alta e addirittura superiore, ma riportata il più possibile al grado medio colloquiale in virtù anche di tutta una serie di immagini e similitudini del mondo della natura alla maniera lussureggiante dei cantici biblici.
Il protagonista del libro Almustafà, il Prediletto (uno degli appellativi di Maometto), è in attesa della nave che lo riporterà nel suo paese natale, dopo gli anni trascorsi nella terra di Orphalese. Alla gente che lo implora di rimanere, Almustafà parla per bocca di Dio: è un mezzo, un tramite che, quando solleva la lanterna per far luce, chiarisce subito che non è sua “la fiamma che vi brucia dentro” ma proviene dall’alto dei cieli. “Profeta del Signore” lo chiama la veggente Almitra: “colui che rivela l’assoluto”, al quale gli altri chiedono di rivelarli a se stessi, di aprire loro gli occhi su “quanto corre tra vita e morte.” Ma quel “cercatore di silenzi” svela di essere incapace ad esprimere “il suo segreto più profondo” se non è Dio a illuminarlo con la sua luce e, in ogni caso, ribadisce che non può che metterli sulla via della conoscenza sulla quale dovranno muoversi da soli. La soluzione del discorso profetico vale a inglobare con naturalezza anche il disegno allegorico che si cela dentro la figurazione del Profeta e che è stato rivelato dal primo biografo, amico e depositario delle confidenze dell’autore, Mikhail Naimy. Nel riscontro dei dati autobiografici, i dodici anni che Almustafà trascorre in attesa della nave sarebbero gli anni vissuti da Gibran in America, fino alla stesura del suo libro. E, in quest’ottica, la città di Orfalese è New York, dove a un certo punto aveva deciso di risiedere attratto dall’intensa vita culturale che vi si svolgeva. La sacerdotessa che “per prima lo cercò e credette in lui” è l’amica e mecenate Mary Haskell, che molto aveva fatto per lui sia come fonte di ispirazione sia sostenendolo materialmente. L’isola nativa per la quale si imbarca è il Libano, la terra di riferimento. E, infine, la promessa di fare ritorno tra la gente di Orfalese è la sua fede nella reincarnazione. Il progetto allegorico vuole realizzare nel vivo della stessa persona di Gibran quella fusione di elementi e di parti che l’autore auspicava e perseguiva anche nella sua quotidianità, alimentando durante la vita l’immagine di sé come di un vate predestinato a pronunciare la possibile coniugazione degli opposti. In una chiave che non esclude affatto la sincerità della convinzione, nella cornice di quel misticismo orientale della continua rinascita di cui Gibran è parte integrante nonostante il suo cristianesimo. Perché, come ha scritto Giampiero Bona, “non dimentichiamoci che Gibran è e resta un vecchio arabo, convinto che colui che abbandona la terra con le proprie colpe è costretto a rinascere finché non riuscirà a infrangere l’ultimo legame con la terra stessa.”
È nello spazio vitale del misticismo orientale (una miscela di buddismo, induismo, islamismo) che l’allegoria di cui si è detto può essere interpretata anche secondo uno schema più ampio, universale addirittura, come è stato fatto. Possiamo allora assumere Orfalese a simbolo del mondo e l’esilio di Almustafà a distacco dello spirito individuale dall’Assoluto, durante il suo pellegrinaggio terreno. Il ritorno all’isola nativa rappresenta, in questo caso, il ricongiungimento al cuore dell’Assoluto, l’auspicata espansione dell’individuo nella vita universale.
I grandi temi e le occasioni della quotidianità
Prima di partire per la sua “isola nativa”, in risposta alle richieste incalzanti della gente di Orfalese, Almustafà pronuncia i suoi discorsi intorno al “segreto più profondo” che avvolge gli uomini e la loro presenza misteriosa sulla terra. Il Prediletto parla con eguale attenzione e partecipazione tanto dei grandi temi come l’Amore, la Gioia e il Dolore, la Conoscenza, il Bene e il Male, la Bellezza, la Morte, quanto degli aspetti più immediati e concreti della vita quotidiana. Le rivelazioni di Almustafà partono dall’argomento che è portante nelle intenzioni di Gibran: l’Amore (“Seguitelo, quando l’amore vi comanda. / Anche se le sue vie sono scoscese e dure”). L’amore investe e attraversa l’uomo come una forza possente e incontenibile che rivela a ciascuno “i segreti del cuore” e, in questo modo, ne fa “parte del cuore stesso della vita”. Per paura, dice Almustafà, si cerca nell’amore solo il piacere. Il piacere è un abbaglio, ma è anche una spia luminosa verso altri bersagli. Per questo non va respinto, ma preso per quello che vale. È un modo di cercare e di dare briglia al desiderio, che altrimenti sprofonda nei recessi dell’essere con ben altre nefande conseguenze: “Il piacere è un canto di libertà. / Ma non è affatto libertà. / È la fioritura dei vostri desideri. / Ma non il loro frutto. / È un abisso che spinge verso l’alto. / Ma non è il fondo e non è la cima”. L’amore è molto più del puro piacere: una luce che riscatta e nobilita. Un qualcosa di compiuto e di autonomo, in un’accezione del tutto moderna: “L’amore non dà altro che se stesso e non prende nient’altro che da sé. / L’amore non possiede né vuol esser posseduto. / Perché all’amore l’amore basta in tutto.” Senza secondi fini: “Perché l’amore che non cerca se non di rivelare / il suo mistero, non è amore, ma una rete lanciata avanti: / ed è solo ciò che è vano a cascarci dentro”. L’amore è il principio positivo dell’aggregazione: ciò che unisce e, cementando, rende possibile la grande costruzione. A partire proprio dal nucleo primario che è la congiunzione di uomo e di donna: “Insieme siete nati e insieme, per sempre, rimarrete”. Con una ben precisa indicazione: “Ma che vi siano spazi nella vostra unione. / Amatevi l’un l’altro, ma non fate una prigione dell’amore.” Perché l’unione è forte se sono salde le individualità che la compongono. L’essere insieme dà il massimo delle sue potenzialità quando ciascuno sa stare da solo: “Come sole sono le corde del liuto, anche se vibrano della stessa musica insieme”, come le colonne del tempio che stanno su insieme, ma ciascuna per suo conto, e come la quercia e il cipresso che “non crescono mai l’una all’ombra dell’altro”. Questa autonomia nell’unione vale del resto in tutti i rapporti, anche nell’amicizia. Quell’amicizia in cui l’essere d’aiuto, di sostegno, di mutuo conforto l’uno all’altro risponde a una disposizione positiva: “Sia per l’amico la parte migliore di voi stessi. / E, se lui deve conoscere il riflusso della vostra marea, ne conosca però anche la piena. / Per cosa è amico vostro se lo cercate solo per ammazzare il tempo? / Cercatelo invece per vivere appieno insieme a lui”. In un’ottica, sempre, di partecipazione attiva: “Perché è lì ad aiutarvi nel bisogno, ma non per riempirvi il vuoto”.
Il tema dell’amore per Gibran, lettore dell’illuminismo francese ma anche interprete della tradizione del pensiero orientale, si lega al rispetto dell’individualità. Il fondamento, anche dell’amore, è la libertà “sacra” dell’individuo, ribadita per ciascuno fin dall’inizio, a partire dalla condizione di figlio: “I vostri figli non sono vostri. / Sono figli e figlie del desiderio che la vita ha di se stessa. / È attraverso di voi che vengono, ma non da voi. / E, benché vivano con voi, ciò non di meno non vi appartengono”. Ecco perché si ribadisce la tutela della loro integrità, dell’indipendenza della loro personalità: “Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. / Perché, di idee, hanno le loro. / Potete custodire i loro corpi, ma non le anime. / Perché le loro anime abitano la casa del futuro, che neppure in sogno voi potete visitare. / Potrete cercare di somigliare a loro, ma non potrete farli simili a voi. / Perché la vita procede e non si attarda mai sopra il passato”. Il monito ai genitori si risolve in un’immagine eloquente delle misure enormi e superiori che vengono da un progetto che ci sovrasta e di cui ci sfuggono gli orizzonti: “Voi siete gli archi da cui come frecce vive i figli sono scoccati avanti. / L’Arciere vede il bersaglio sull’orizzonte dell’infinito e con la forza vi tende perché le frecce vadano rapide e lontane”. Del resto, il rispetto della libertà non si trasforma in culto. Gibran ammonisce: “quella che voi chiamate libertà è la più forte delle catene”, perché pensando di diventare libero l’uomo rinuncia a parte di se stesso. La libertà non è un’astrazione, non è un fine o un compimento, ma un essere disponibili e pronti: “Sarete liberi davvero non quando i vostri giorni saranno senza pena e le notti senza bisogno e senza dolore. / Ma piuttosto quando queste cose stringeranno come una cintura la vostra vita e voi saprete levarvi sopra a tutto nudi e senza catene”. Siamo nell’ambito di una problematica della conoscenza come processo del profondo che l’uomo si sforza di esteriorizzare. Ma tra la rivelazione e la consapevolezza si compie un lento e lungo processo che passa attraverso la pronuncia della parola: “I vostri cuori conoscono in silenzio i segreti del giorno e della notte. / Ma le orecchie hanno sete di ascoltare quel che il cuore sa. / È che vorreste conoscere a parole quel che sentite intanto nel pensiero. / E vorreste toccare con le dita il corpo nudo dei vostri stessi sogni”.
La conoscenza, per Gibran, è una scommessa perduta in partenza: “Ai vostri occhi dovrà svelarsi un giorno il tesoro della vostra infinita immensità. / Ma non lasciate che una bilancia pesi questo tesoro ignoto. / E non sondate con l’asta o lo scandaglio le profondità della vostra conoscenza. / Perché l’io è un mare immenso e sconfinato”. E la conseguenza è che: “Nessuno può insegnarvi nulla, se non ciò che giace mezzo addormentato nell’albore della vostra conoscenza”. Perciò il maestro veramente saggio è quello che guida ciascuno sulla soglia della propria mente senza pretendere di consegnargli quel che lui ha conosciuto. Il problema gnoseologico viene riportato più semplicemente alla ricerca di un equilibrio tanto caro alla tradizione del pensiero orientale. Per la necessità di far convivere, dentro di noi, ragione e passione, insieme unite per il meglio: “Perché, se la ragione domina da sola, è una forza che imprigiona. E la passione, quando è incustodita, è una fiamma che brucia alla sua stessa distruzione”. La ricerca dell’equilibrio passa attraverso la sofferenza: il soffrire non solo è inevitabile, ma necessario, perché “La sofferenza è il rompersi del guscio che chiude la vostra conoscenza”. È qualcosa che fa parte integrante della vita. È la cadenza stessa secondo cui la vita procede per rispecchiare su di sé la gioia. Gioia e sofferenza sono le due facce della stessa medaglia. La coincidenza degli opposti è per Gibran, del resto secondo la tradizione del pensiero orientale, una delle leggi che regolano la vita: “cos’è mai il male, se non un bene torturato dalla propria fame e dalla propria sete?”. È la legge fisica dell’inversamente proporzionale, quella per cui ogni azione determina una reazione uguale e contraria. E vale non solo quando ci muoviamo nello spazio, ma anche quando pensiamo e sogniamo. Ogni entità è sempre delineata per contrasto dal vuoto a cui dà confine e, allo stesso modo, ogni comportamento è condizionato dal suo contrario, in una sorta di inestricabile combinazione chimica. Così accade, ad esempio, che nella colpa ci sia sempre una corresponsabilità, una complicità tra vittima e carnefice che rende più complesso il nodo delle responsabilità: “L’assassinato non è mai del tutto estraneo al suo assassinio, / E il derubato non è senza la colpa del furto che ha subito. / Il giusto non è innocente delle cattive azioni commesse dal malvagio. / E chi ha le mani intatte non è immune dai delitti compiuti dal delinquente più scellerato. / Ebbene sì, il colpevole è spesso la vittima del suo ingiuriato. / E più spesso ancora il condannato porta la croce per chi è privo di colpa e di condanna”.
Non si può “affatto separare il giusto dall’ingiusto e il buono dal cattivo”. E, in tutti, agisce una tendenza irresistibile a trasgredire le leggi: è un crescere per contrasti e trasgressioni, che sconcerta e lascia inquieti, desiderosi di sublimazione. Ma nel difetto e nel dolore, nel bisogno e perfino nella disperazione. Così, appunto, accade nella preghiera: “Voi pregate nella disperazione e nel bisogno, ma dovreste pregare pure nella pienezza della gioia e nei giorni di abbondanza”. Per pregare, basta entrare nel “tempio invisibile” che è la vita stessa, il sui fluire nelle cose animate e inanimate: “la vita quotidiana è il vostro tempio e la vostra religione”. Il bisogno di sublimazione rincorre un’immagine perfetta di se stessi, forse impossibile, ma comunque specchio di un’eternità che ci chiama. Proprio come accade sulle tracce della bellezza e ciascuno finisce con l’identificare la bellezza con i propri bisogni insoddisfatti. Invece la bellezza “non è un bisogno ma un’ebbrezza”. Di più, addirittura: “è la vita stessa, quando la vita toglie il velo e rivela il suo volto sacro”. E anche la bellezza è “eternità che si contempla allo specchio”. Il tempo è una convenzione che rischia di far perdere all’uomo il senso delle proporzioni. Perché, nel suo insieme, la vita è senza tempo e, in questa progressione all’infinito, il tempo stesso è illimitato. La piccola porzione che appartiene a ciascun uomo è la scansione di un’eternità che sovrasta tutto e tutti. Per abituarsi a tale dimensione, ognuno dovrebbe cominciare a considerare la propria vita in un sincronismo secondo cui “il presente abbracci con il ricordo il passato e il futuro con l’attesa”. Così, il segreto della morte risiede nel cuore stesso della vita, secondo quella coincidenza degli opposti di cui si è detto: “Se volete conoscere davvero lo spirito della morte, spalancate il vostro cuore al corpo della vita. / Perché vita e morte sono una cosa sola, così come una cosa sola sono il fiume e il mare”. Anche se non è facile per l’uomo disporsi in quest’ottica, per guardare dentro la morte. Al fondo delle speranze e dei desideri vive “la muta conoscenza di ciò che sta oltre la vita”. E bisogna avere il coraggio di guardare oltre la propria ombra, perché “nebuloso e vago è il principio delle cose, ma non la loro fine”. L’infinito che è in ciascuno è la speranza stessa e il più acceso desiderio di andare oltre.
Certi indizi della salvezza si colgono, secondo Gibran, in modo inversamente proporzionale: ciò che appare fragile e confuso, nell’uomo, è invece la parte più forte e addirittura decisiva: “Non è forse il respiro che ha eretto e indurito la struttura delle vostre ossa? / E non è forse il sogno che nessuno di voi ricorda di aver sognato che ha costruito la città e tutto quanto la città contiene?” Del resto, il segreto ha la sua ragione e il sigillo aspetta di essere spezzato: “Il velo che vi copre gli occhi sarà di colpo sollevato dalla mano che ve lo ha intessuto. / E la creta che vi tappa gli orecchi sarà rimossa dalle dita stesse che l’hanno impastata. / E voi vedrete, finalmente. / E sentirete. / E non rimpiangerete di aver provato la cecità, né vi dorrete di essere stati sordi. / Perché in quel giorno saprete le ragioni occulte di ogni cosa. / E benedirete le tenebre come avreste benedetto la luce”. Resta, dunque, una disposizione positiva nei confronti della vita, nel segno di quella gioia e di quella pienezza più volte da Gibran pronunciate. Credere alla vita e alla sua generosità rende istintivamente disponibili e pronti ad anticipare qualsiasi richiesta e a far fronte a ogni necessità degli altri. Perché la vita chiama la vita, nel segno dell’affermazione, e “negare è un po’ morire”. Contro ogni pessimismo indotto: “vi è stato detto che la vita è tenebra e voi, / nella vostra stanchezza, ripetete le parole di chi è stanco. / Ma io vi dico invece che la vita è tenebra soltanto / se manca lo slancio”.
Il gusto della vita è alla base del poema di Gibran, che proprio per questo affronta anche i temi concreti della quotidianità (“La vita quotidiana è il vostro tempio e la vostra religione”), secondo una pratica sapienziale di tradizione orientale che entra nel merito degli stessi processi fisiologici, degli usi e delle abitudini, del lavoro, dei modi e dei luoghi in cui la vita si compie. Occupandosi del mangiare e del bere, della casa, dei vestiti, del commercio e di ogni altra cosa, ufficio, occupazione, con cui occorre fare i conti ogni giorno. Si trova così, nel discorso di Almustafà, la giustificazione di quella fisiologia che fonda la vita sulla morte, in una forma di panteismo misticheggiante: “Ma, visto che dovrete uccidere per poter mangiare, e derubare il nuovo nato del suo latte materno per spegnere la sete, sia allora un atto di adorazione il vostro. / E la mensa sia un altare sul quale i puri e gli innocenti di campi e di foreste si immolino per quel che di più puro e innocente c’è nell’uomo”. Si affermano le ragioni di un “naturismo” ante litteram a proposito di quei vestiti in cui l’uomo cerca “la libertà interiore” e in cui trova piuttosto “briglie e catene”, nella direzione di un ritorno all’immediatezza della natura, che copre il corpo solo per necessità, pronta di nuovo a scoprirlo perché abbia un suo rapporto diretto con il sole, con il vento, con la terra. Memore della vita nel suo paese, a confronto con le abitudini occidentali, Gibran mette in bocca al suo profeta parole di fuoco nei confronti delle case divenute “sepolcri” in cui si chiudono i vivi. Nel rifiuto di quell’idea di paura che ha fatto della casa, nel tempo, occasione di ricovero e di difesa dai pericoli esterni più che zona franca dei sentimenti e contenitore della gioia di vivere, palcoscenico delle vanità e cassaforte degli averi più che luogo di incontro e di partecipazione. Il monito, nel fondo, è di specie etica: l’avidità annulla ogni aspirazione e uccide la passione dell’anima. La casa non deve essere “un’ancora ma un albero di nave”, per essere il teatro della vita e non un’anticipazione della tomba: “Cosa tenete in queste vostre case? Cosa ci custodite mai, sbarrato dietro le porte? / È pace che ci tenete dentro ben protetta, la calma passione che rivela la vostra potenza? / Ci custodite i ricordi, quegli archi di pallida luce che collegano a un tratto le sommità della mente? / O proteggete là la bellezza che dagli oggetti di legno e di pietra trascina i cuori più in alto alle vette del sacro? / Ditemi allora, son queste le cose che tenete in casa ben chiuse? / O ci custodite soltanto le ricchezze e l’avida sete che ne nasce ed entra in casa furtiva da ospite diventando padrona?”
Il successo
Proprio i temi dell’esistenza spirituale e corporea, affrontati nella chiave profetica e immaginosa di un discorso semplice ma suggestivo, sono il segreto del grande successo che il Profeta ha sempre raccolto tra il pubblico dei lettori. Al punto di creare, mentre l’autore era ancora in vita, un mito intorno alla figura di Gibran. E si deve aggiungere che, addirittura, Gibran abbia costituito un fenomeno sul piano sociologico. Lo ricordava Carlo A. Corsi, sottolineando come fosse uno scrittore di tempi di crisi e come la sua fortuna americana risalisse proprio al momento del tracollo economico del ’29 e avesse seguito gli alti e bassi di quella società, a seconda che si trattasse di momenti in cui prevaleva l’ottimismo riformatore o il pessimismo conservatore, per tornare in auge alla fine della seconda guerra mondiale e poi negli anni sessanta in area beat e consolidarsi all’interno dei movimenti New Age. Ma, a differenza del successo di pubblico, Gibran non ha mai incontrato il favore della critica, scettica nei confronti della sua materia estremamente ibrida e sospettosa nei confronti dell’intonazione sostenuta della sua poesia. Un rifiuto, quello dei critici letterari, motivato anche dalle ragioni storiche di un netto ritardo di Gibran rispetto alla grande poesia degli anni venti-trenta e, in particolare, di quella in lingua inglese. Quando infatti nel 1923 uscì il Profeta, Eliot aveva già pubblicato The Waste Lande e Pound aveva scritto il famoso Hugh Selwyn Mauberley, testi che avevano creato nuove forme e tecniche del verso, destinate ad influenzare a livello mondiale la poesia del Novecento. Gibran procedeva per suo conto, da isolato, e aveva il riferimento decisamente tradizionalista della poesia coeva in lingua araba. Secondo Barbara Young, sua biografa prediletta, l’idea di scrittura a cui Gibran si conformava era “la parola inevitabile al suo posto inevitabile”. Ma non si può dire che vi sia stato sempre fedele. Come dice un suo verso di Sabbia e spuma: “Metà di quel che dico non ha senso, ma lo dico perché l’altra metà possa arrivarti” (Half of what I say is meaningless, but I say it so that the other half may reach you), e può considerarsi la conferma più o meno diretta di una certa sovrabbondanza e ripetitività nella sua scrittura. Secondo Nicola Crocetti, “continuamente in bilico tra il sermone e l’epigramma, tra la parabola e l’aforisma, la prosa poetica di Gibran ha un andamento ritmico ora lirico-rapsodico, ora didascalico e retorico”. È ricca di similitudini naturali e di allegorie visionarie che richiamano i Salmi e l’Apocalisse e che le conferiscono una innegabile suggestione. Il fascino dei libri profetici, della loro immaginosità visionaria, nonostante il ritardo culturale e il reimpiego di schemi di maniera, potenziati da una considerevole “genialità psicologica” e da una capacità di reinterpretare in maniera brillante le notazioni di un’antropologia culturale spicciola, ha consegnato il Profeta alla lettura comunque interessata anche dei palati più fini. Alla luce di quel dato del sublime che, nonostante tutto, continua ad essere una delle aspirazioni più diffuse della poesia di tutti i tempi, con la sua esigenza continuamente rinnovata di dare forma eterna alle verità della vita. È calzante ed equilibrata la definizione che del Profeta ha dato Suheil Bushrui: “La verità è che si tratta di un’opera ricca di pietà, intuito, speranza e ispirazione, che trasmette un messaggio eterno in cui si uniscono la dignità della Bibbia cristiana e la saggezza dei sufi islamici. Un messaggio formulato con una semplicità e una qualità ritmica che lo rendono del pari interessante ai più esigenti e accessibile a un’ampia cerchia di lettori”.
La vita
Jibran Khalil Jibran nasce il 6 gennaio del 1883 a Bisharri, grosso villaggio nel nord del Libano, in una famiglia numerosa e di modeste condizioni. Il padre emigra presto negli Stati Uniti, in cerca di lavoro e di fortuna, con l’intesa che i familiari lo raggiungano dopo che avrà trovato una sistemazione stabile. Nel 1894, parte per l’America con la madre Karima e le sorelle Mariana e Sultana per raggiungere il padre, stabilendosi presso il fratellastro Butrus, a Boston, dove c’è una grossa colonia di libanesi di Bisharri. A Boston, dove ha assunto il nome di Kahlil Gibran per adattare la grafia alla pronuncia dell’inglese, il bambino undicenne intraprende gli studi: prima presso la scuola comunale di Quincy e poi in una scuola serale. L’interesse per le materie di studio e una spiccata disposizione naturale fanno sì che, nel 1897, venga inviato dalla famiglia a Beirut, per completare la sua educazione. In Libano, frequenta il collegio al-Hik-mat, gestito dal clero maronita: la famosa Scuola della Saggezza, dove apprende l’arabo accanto al francese e alle materie scientifiche, in un’atmosfera particolare che unisce allo spirito nazionalistico una spiccata intolleranza confessionale. Infatti, i ragazzi del collegio vengono considerati d’ufficio membri della congregazione dell’Immacolata Concezione e sono tenuti all’osservanza di una rigida disciplina. Vincolo dal quale saprà tuttavia liberarsi presto. L’educazione in terra libanese riconduce Gibran alle sue radici più profonde, ma già la nuova patria americana ha lasciato in lui il segno allargandogli l’orizzonte culturale e allenandolo a un bilinguismo con complessi apporti reciproci tra l’inglese e l’arabo. Dopo la conclusione degli studi, viaggia attraverso il Libano e nella vicina Siria, prima di tornare a Boston. Per tutta la vita, da allora in poi, Gibran si muoverà tra gli Stati Uniti e il Libano, in una specie di oscillazione continua legata ai due poli della sua vicenda: la terra di origine, con le sue tradizioni e la sua cultura, e la patria adottiva, non solo fonte di lavoro e di sostentamento per la sua famiglia, ma anche occasione di nuove prospettive umane e culturali. Quasi ventenne, nel 1902, Gibran torna in Libano per l’ennesimo viaggio alle proprie radici. Ma non fa in tempo a concludere le sue visite ai luoghi della regione, perché la notizia della malattia e dell’aggravamento improvviso di sua madre lo richiama a Boston. La trova, infatti, stremata da quella stessa tisi che minaccia e che si porta via successivamente alla madre, morta nel 1903, anche il fratellastro Butrus. La stessa malattia che aveva già consumato, un anno prima, la sorella Sultana. A Boston, Gibran comincia a scrivere in lingua araba per i fogli che si stampano all’interno della comunità libanese, su vari temi religiosi e culturali. Ma già alterna all’arabo l’uso dell’inglese, che andrà coltivando in parallelo alla lingua madre fino a privilegiarlo più avanti nella stesura dei suoi testi. Nel 1904 conosce Mary Haskell, proprietaria e direttrice della Cambridge School, che avrà una grande importanza nella sua vita, sia perché ne ispirerà a più riprese l’opera e sia perché lo aiuterà anche materialmente in diverse occasioni. E quella con Mary diventa un’amicizia decisiva, destinata a prolungarsi in avanti negli anni. Un’amicizia produttiva sul piano dello scambio delle idee, oltre che su quello delle confidenze sentimentali. Proprio l’anno in cui diventa amico di Mary, Gibran comincia una relazione con Emilie Michel, ventenne insegnante d’origine francese della Cambridge School. L’amicizia con Mary Haskell è destinata a svilupparsi in un complesso rapporto che contempla a quel che si capisce anche risvolti sentimentali, testimoniati dai passaggi di numerose lettere, e che in ogni caso evolve in una sorta di collaborazione letteraria di consulenza e di rifinitura da parte di lei che suggerisce a Gibran modalità sintattiche e lessicali della lingua inglese, nel rivedere i suoi testi.
Con l’aiuto finanziario di Mary Haskell, nel 1908, Gibran parte per Parigi, per frequentarvi i corsi di pittura dell’Accadémie Lucien. Il soggiorno parigino è carico di esperienze umane e soprattutto culturali: diventa allievo di Rodin e conosce scrittori coetanei e più anziani, facendo il ritratto a personaggi come il compositore Debussy, l’attrice Sarah Bernardt, il poeta Yeats. Nella vivacità inizio secolo di quella che era già la capitale culturale del mondo, il giovane cosmopolita incontra i grandi testi della tradizione francese, risalendo fino a Voltaire e a Rousseau. E legge in traduzione alcune opere che esercitano su di lui un fascino enorme, al punto da determinarne non poco la poesia. In particolare lo colpisce la visionarietà di Così parlò Zarathustra di Nietzsche. Ma non da meno sono i Canti di William Blake, di cui lo affascina il geniale mescolarsi di simbolismo oscuro, di impulso profetico e di mordente critica sociale. A rivelarglieli è lo stesso Rodin, che li cita spesso e volentieri nel corso delle proprie lezioni, anche perché sente fortemente vicini per sensibilità e ispirazione Blake e Gibran, al punto di affermare a proposito di Kahlil: “non so di nessun altro in cui disegno e poesia siano così uniti da farne un nuovo Blake”, come testimonierà Alice Raphael nell’introduzione ai Venti disegni. Tornato a Boston dopo il lungo soggiorno parigino, nel 1910 Gibran aderisce con convinta partecipazione ai gruppi di ispirazione indipendendista, impegnandosi nella campagna di propaganda a favore dell’emancipazione delle popolazioni soggette al dominio ottomano. Scrive articoli, tiene conferenze, non solo all’interno della comunità libanese. Attratto dal mondo e dalla vita culturale di New York, vi si trasferisce stabilmente nell’autunno del 1912, assieme alla sorella Mariana. Da principio, seguendo la propria vocazione pittorica, intraprende la carriera tipica degli artisti: espone in mostre collettive e personali, ottenendo un buon riscontro critico e suscitando interesse nei confronti dei suoi dipinti che reinterpretano in chiave occidentale la tradizione dell’arte orientale.
A New York, Gibran pensa anche di creare una lega degli scrittori arabi dell’emigrazione. Si preoccupa di organizzare occasioni di incontro tra quelli che chiama “esuli per necessità” e, di lì a qualche anno, fonda con altri interessanti esponenti delle nuove generazioni la “Arrabitah al-qalamiyya”, un’associazione per la rinascita della letteratura in lingua araba. A quel tempo, Gibran comincia la corrispondenza con May Ziadah, una giovane scrittrice libanese residente in Egitto, e nei vent’anni successivi si sviluppa con lei una straordinaria storia d’amore vissuta esclusivamente per corrispondenza epistolare senza mai incontrarla di persona. Nel 1918, Gibran pubblica il suo primo libro in inglese, The Madman (Il pazzo), una raccolta di parabole in stile sufico. Il testo è incentrato sulla follia, in una chiave tra il mistico e il filosofico che diventerà tipica della sua intera produzione successiva, ma qui ancora sotto il vincolo di quella “rivolta contro l’Occidente attraverso lo spirito dell’Oriente”, secondo la definizione stessa dell’autore. Continua ad alternare pittura e scrittura, ma ormai si va evidenziando una sua disposizione particolare per la parola scritta. E, dopo quella specie di canto del cigno che sono nel 1918 i venti disegni “Twenty Drawings”, raccolta dei suoi lavori pittorici con l’introduzione di Alice Raphael, negli undici anni successivi e fino alla morte Gibran scrive numerosissimi libri. Nel 1920 esce The Forerunner (Il precursore), dove ancora dominano le contrapposizioni di bene e male, di morte e eternità, che caratterizzano le contemporanee opere scritte in arabo, come La processione o come Le tempeste.
Intanto, Gibran lavora già alle pagine della sua opera più fortunata, The Prophet (Il profeta), che esce nel 1923 e gli procura subito vasta fama, facendolo conoscere in tutto il mondo attraverso numerose traduzioni. È il libro che più felicemente compendia le diverse anime di Gibran, fuse o per meglio dire ricapitolate alla luce di quel cristianesimo di matrice maronita che sintetizza le diverse istanze culturali, orientali e occidentali, dell’autore e che fa convivere, in una sorta di eresia liberatoria, ortodossia ed eterodossia, monoteismo e panteismo. Un canto profetico nel quale, accanto alle verità della tradizione evangelica, trovano spazio credenze d’altra provenienza religiosa (buddismo, induismo), come la trasmigrazione delle anime. Nel 1926, esce Sand and Foam (Sabbia e onda), una raccolta di pensieri che, in forma epigrammatica, ripercorre per sommi capi e per massime lo spazio già coperto dalla poesia più distesa del Profeta. Nel 1928, Gibran pubblica Jesus the Son of Man (Gesù figlio dell’uomo), una sorta di vangelo apocrifo o di testo parallelo che ripercorre la storia del Cristo, come recita il sottotitolo: “Le sue parole e le sue azioni come sono state raccontate e trasmesse da quelli che lo hanno conosciuto”. Intanto, minato sempre più nella salute, Gibran alterna al lavoro di scrittura periodi di forzato riposo. Un principio di tubercolosi lo lega al destino che ha sterminato buona parte della sua famiglia. Ma, a questi problemi, si aggiunge un certo disordine di vita e in particolare l’abuso di alcolici. La cirrosi epatica contribuirà a condurlo alla morte, avvenuta il 10 aprile del 1931, neppure cinquantenne. Secondo il suo desiderio di essere sepolto in Libano, la sua salma viene trasportata con grandi onori nella sua terra natale. La sorella Mariana e Mary Haskell acquistano il Monastero Mar Sarkis (San Sergio) dove il corpo di Gibran trova posto in un monumento funebre.
Nello stesso anno viene pubblicato The Earth Gods (Le divinità della terra), che è l’ultimo libro rivisto e licenziato dall’autore. Nel 1932, esce il primo dei nove libri postumi di Gibran: The Wanderer (Il vagabondo), cui fa seguito l’anno dopo The Garden of the Prophet (Il giardino del Profeta), che è il secondo volume rimasto incompiuto del Profeta, incentrato sul rapporto dell’uomo con la natura e con Dio, secondo atto di una trilogia mai realizzata. A rivedere il libro era stata Barbara Young, compagna degli ultimi anni di Gibran. La raccolta delle prose e delle poesie di Gibran esce a New York nel 1934: Prose Poems, un ampio volume miscellaneo che offre in edizione critica i testi brevi (saggi, interventi, scritti preparatori, commentari, appunti) e la varia e discontinua produzione poetica. Nel 1947, quasi contemporaneamente, escono alcuni scritti mistico-filosofici di Gibran: saggi, versi, prose varie, in gran parte redatti in arabo e pubblicati su riviste e tradotti in inglese, in qualche caso dall’autore stesso e per la maggior parte a cura dell’editore, sull’onda del successo del Profeta che si rinnova nel secondo dopoguerra: Tears and Laughter (Lacrime e sorrisi), Spirits Rebellious (Spiriti ribelli) e Secrets of the Hearth (I segreti del cuore). In generale, si tratta di racconti brevi o veri e propri apologhi, “parabole poetiche” secondo la definizione che ne è stata data, scritti che hanno come sfondo il Libano e come sostanza quell’idealismo tra l’ideologico e il religioso che caratterizza l’esperienza di Gibran e nei quali si ritrovano non soltanto i temi, ma le figure e le situazioni ricorrenti nella sua intera produzione. La follia e l’imitazione di Cristo trasformate in un’allegoria del conflitto tra lo spirito del Vangelo e la tirannia del fanatismo religioso, la fede nella reincarnazione delle anime, la raffigurazione del cristianesimo come uno dei rani di un’unica religione universale, il Vangelo considerato come fonte di un’idea d’amore ecumenica e assoluta, la convinzione che l’autorità delle Scritture è da anteporre a quella della chiesa, l’idea manichea che contrappone nettamente bene e male, il rifiuto della civiltà moderna considerata come un vecchio albero corrotto. Questi sono i temi, come li ricapitola e sintetizza Nicola Crocetti, nell’introduzione alla traduzione italiana dei Segreti del cuore. In quello stesso 1947, esce The Procession (La processione), un’opera scritta in arabo nel 1919, importante per il passaggio che segna, nell’esperienza dell’autore, “dal mondo della denuncia e della ribellione a ogni precostituita differenza tra uomo e uomo, al mondo della riflessione epocale, apocalittica e simbolica della parola come unica intermediaria tra il sogno e la realtà” (B. Pirone). Gli ultimi due libri di Gibran, traduzioni di opere già pubblicate in arabo, vedono la luce, il primo, nel 1948, a diciassette anni dalla sua morte, Nymphs of the Valley (Le ninfe della valle), e il secondo, nel 1950, a ben diciannove anni dalla morte, A Tear and a Smile (Una lacrima e un sorriso), a cura di Alfred Knopf di New York, il suo primo e quasi unico editore.
Paolo Ruffilli
Specifiche
- Pagine: 112
- Anno Pubblicazione: 2017
- Formato: 13,5 x 20
- Isbn: 9788898613984
- Prezzo copertina: 12,00