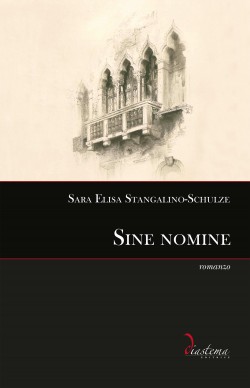Sara Elisa Stangalino-Schulze
Sine nomine
Un uomo che possiede ogni tipo di potere eccetto quello di salvare sé stesso, un coleridgiano Ancient Mariner prigioniero di uno scenario noir aggravato da una serie di misteriosi decessi sullo sfondo di una Venezia spettrale, gotica, ma dalla quale emergerà al contempo la chiave per il definitivo riscatto: Ottaviano Schmidt non può invecchiare, sarà condannato a sopravvivere fino a che non avrà risolto la situazione che ha complicato, un dilemma che incombe sul piano della coscienza intesa come luogo suscitatore dell’operato umano.
Piano sensibile, metafisico e dimensione simbolica si intrecciano senza soluzione di continuità nell’indagine sull’eterno dramma della responsabilità umana, in una vicenda dove la musica sigilla il lungo cammino verso la riconquista del sé e la conseguente ascesa a un livello di coscienza superiore.
Una lettura avvincente, con segnali di poesia che offrono insieme sicurezza e originalità personale. Sfumato e fermezza si alternano e compensano nello stile così come nelle atmosfere evocate. I personaggi esistono, la storia si fa strada, continua, precisa, fra tanto fluttuare di luoghi e piani di percezione-visione. Un momento di raro godimento e sensibilità aerea, fonda, stimolante. (Franca Cella)
Primo capitoloPro Logos
Se dunque tu ti prostri per adorarmi, sarà tutto tuo.
Luca IV, 7
Venne da me l’altra notte. Non potei rifiutarmi di accoglierlo. Quando entrò fu subito chiaro che non era lì per negoziare: Roma lo aveva mandato apposta perché io mettessi quella firma. L’alto lignaggio dei servitori che lo accompagnavano, il suo abito tanto più sfarzoso del mio, tutto diceva che gli dovevo obbedienza. Un abito che lo professava uomo di Dio, più degli altri, e che gli diede presto modo di manifestarmi tutta la sua cristiana carità.
Quasi si rallegrò che le carte per il processo fossero pronte, che presto ci saremmo tolti di torno la ragazza. Ma – disse – le cose dovevano affrettarsi perché gli uomini del padre di lei si stavano muovendo e non si poteva permettere che la Chiesa venisse soverchiata da un procuratore veneziano.
In tutta quella faccenda c’era però una cosa che il cardinale ignorava. Ignorava che appena qualche giorno prima, dopo un lungo, penoso periodo trascorso a moderare le asperrime lotte che opponevano il mio ego e la mia coscienza, avevo infine risolto di lasciare l’abito. Sì: una decisione grave, presa in poco tempo, in gran segreto e, soprattutto, nel terrore per le ovvie conseguenze che quella scelta avrebbe comportato.
Qualche giorno prima avevo ricevuto una lettera che mi ordinava di fare arrestare quella donna. Anche se non credevo a una soltanto delle accuse che le erano state rivolte, ho obbedito, e, senza averla mai vista in volto, avevo firmato. Se Roma mi ingiungeva di mettere agli arresti la figlia di un procuratore della Serenissima, era altrettanto chiaro che io non dovevo in nessun modo presumere di conoscerne i motivi. Non discussi: ero al mio primo incarico, era un ordine degli inquisitori del Sant’Uffizio; non so come il mio nome fosse finito nelle mani dei porporati.
La ragazza fu condotta nel mio ufficio perché la vedessi e perché la interrogassi prima che la rinchiudessero. Chiesi, ed ottenni, che ci lasciassero soli per qualche minuto. So di non possedere nemmeno oggi saggezza bastante a comprendere i giochi del destino e i suoi scacchi, ma so per certo che soltanto allora compresi tutto l’orrore del mio gesto. Trascorrevo le notti davanti alle sbarre della sua cella cercando di darle un conforto che io stesso le avevo tolto. Era molto debole, rifiutava il cibo, sarebbe in poco tempo morta di stenti ma mi aveva visto, e tra le sbarre aveva afferrato le mie mani e le aveva riconosciute: erano le stesse mani che qualche anno prima avevano bussato alla porta di suo padre per chiedere la sua. Quell’uomo mi aveva scacciato; in quella disperazione soltanto in Dio avevo trovato conforto: fu naturale che decidessi di darmi a Lui completamente.
Non trovai nulla di meglio che riferire tutto al cardinale, con un’onestà che quell’uomo non poteva concepire e, di conseguenza, nemmeno comprendere. Era venuto da me tra le ombre della notte per dirmi che mi capiva, che non ero né il primo né l’ultimo a desiderare di lasciare l’abito dopo l’affido della prima commissione, che la prima volta era la più difficile ma che col tempo mi ci sarei abituato, che quella era la mia grande occasione per capire il valore dell’obbedienza.
Cercai di oppormi ma, prima che potessi verbalizzare il mio rifiuto, lui accennò a uno dei suoi uomini il quale da sotto il tabarro tirò fuori un piccolo forziere. Lo aprì e ne estrasse un vaso di cristallo di rocca, tutto orlato in argento. Conteneva una massa di grandi perle dalla forma irregolare, coloratissime; valevano una fortuna. Vacillai di fronte a quell’offerta, lo confesso, per il valore dell’oggetto, certo, di più per il significato di quella promessa. Al volo il cardinale prese vantaggio dalla mia debolezza. Mi disse che sarebbe stato soltanto il primo dei doni che avrei ricevuto, che erano già preparati per me, lasciando intendere che ne sarebbero seguiti di ben più ricchi, temporali e spirituali. Diede ordine di posare il vaso sulla mia scrivania, poi accennò alla cartella nera che tenevo in mezzo al tavolo e mi chiese di estrarre gli incartamenti del processo. Insistette. Non avevo scelta. Sfogliò, lesse, tirò fuori una carta e mi intimò di apporre seduta stante la mia firma. Con quella consegnavo l’imputata nelle loro mani. Nei fatti, era la sua condanna alla pena capitale. Obiettai argomentando che il processo non aveva ancora avuto luogo ma lui controribatté dicendo che quelli non erano affari miei e che ci avrebbero pensato poi ‘loro’ a far quadrare i conti. Mi comandò di sedere, di prendere in mano la penna e di intingerla nel calamaio. C’era poca luce: il baluginìo di quattro candele riusciva soltanto a rendere più visibile l’oscurità, a forgiare ombre che si fondevano con quelle che la mia mente rigurgitava. Non vedevo più né carta né calamaio, soltanto ombre che calavano sui miei occhi e mi levavano la vista. Ero seduto, avevo la penna in mano, le mie dita erano sporche d’inchiostro, ma per nessun motivo al mondo avrei poggiato il pennino sulla carta.
Gli dissi che stava facendo di me un assassino e che le sue perle se le sarebbe anche potute riprendere. Fu allora che il bravo mi puntò una pistola alla testa:
– Firma, – disse con un filo di voce, senza che il cardinale muovesse ciglio.
Non sapevo se avrei mai più rivisto la luce del sole, il terrore fu così grande che mi bloccò. Il bravo allora impugnò la mia mano, mi forzò a scarabocchiare il documento e infine ci ficcò su il sigillo.
Ero convinto che, non appena avessero lasciato la stanza, avrei potuto scendere nelle carceri, tirarla fuori, riportarla a Venezia dove sarebbe stata in salvo. Ma non mi fu possibile: appena vergato quel foglio mi furono tolte tutte le chiavi, mi presero e mi gettarono nella stessa cella dalla quale, quasi nello stesso istante, prelevarono lei. Non ebbi che pochi attimi, troppo poco per spiegarle. Non la vidi più né dopo quella notte seppi più nulla di lei.
Ero certo che sarei morto tra le sbarre di quel carcere, invece qualche giorno dopo mi vennero a prendere e mi imbarcarono su una galea. In pochi giorni raggiunsi un’isola. Seppi poi che mi avevano condotto a Cipro, al confino. Giravano voci a proposito di una guerra che era scoppiata, dicevano che Venezia stava proteggendo Candia. Ma nella rocca dove io ero confinato non si poteva sapere di più.
Volle il caso che non mi trovassi in un carcere bensì nella fortezza di un patrizio che intratteneva affari con Venezia. Un posto lontano da ogni guerra, lontano da ogni dolore, ma dal quale non potevo fuggire. Senza tentare la fuga, non mi rassegnavo però a vivere in quelle stanze, per quanto quel lusso rendesse più sopportabile la mia solitudine, per quante pietre dure rischiarassero le pareti del mio carcere, per quante candele bruciassero e incensi purificatori, per quante bianche mani di mute tessitrici accarezzassi mentre intrecciavano gemme e fili d’oro.
Erano nate molte dicerie intorno alle mura di quella rocca, molto avevo sentito raccontare dagli abitanti dell’isola; di come i giardini del castello conservassero gli ultimi esemplari delle rose di Babilonia e altre sciocchezze del genere. Sciocchezze, ho detto. Però, a dire il vero, dopo giorni e giorni di attenta osservazione sarei stato in grado di dare per certo che le rose di quel giardino non sfiorivano.
Sentivo intanto il tempo scivolare tra le ampolle che dondolavano dai soffitti, variopinte stalattiti di sale antico, quelle che più d’una volta nei miei viaggi avevo veduto pendere dalle volte delle fortezze sul mare. La luce che pulsava negli alabastri policromi dava loro un’anima dubbia, un’anima incapace di disfarsi del tutto della notte intorno, nonostante il loro pulsare intenso, vivido.
Ma nel caldo silenzio delle notti orientali, tormentato dal rimorso, non avevo mai smesso di pensare alla donna della quale avevo mio malgrado decretato la morte e che però – ne ero certo – doveva essere ancora viva.
Fu allora che accadde qualcosa di inimmaginabile. Una notte feci uno strano sogno. Era l’alba, stavo percorrendo i bastioni di un forte; il sole era appena sorto oltre l’orizzonte, mi penetrava con quel suo occhio ardente sicché io non ero in grado di reggerne la vista e procedevo zoppicando, facendo ombra agli occhi con la mano. Scesi una scala di roccia, fin giù lungo la spiaggia. Là sul bagnasciuga vidi una giovane donna, mi precedeva e mi faceva cenni di seguirla. Affrettai il passo senza tuttavia riuscire a raggiungerla, quando a un certo punto vidi la sua silhouette scomparire dietro un’insenatura lontana. Corsi in quella direzione lungo la spiaggia, indi fiancheggiai la roccia finché alla mia sinistra vidi il sasso aprirsi in un fiordo, profondo, maestoso, che riceveva una gran luce dall’alto sicché mi fu possibile vederne la fine. Ci entrai e, l’acqua alle ginocchia, camminai attraverso fino in fondo, dove emergeva una piccola spiaggia. Oltre la spiaggia, appena qualche metro più in là, s’impose ai miei occhi la vista di un impressionante adito: era la porta di una chiesa. Una porta di dimensioni titaniche, scolpita nella parete sinistra del fiordo, s’innalzava per tutta l’altezza della sua roccia. Abbarbicata alle sue lesene che si perdevano nell’alto dei cieli era la più grande messe di piante e arboscelli che avessi mai avuto modo di vedere, una varietà di uccelli esotici dai colori sconosciuti cantava quasi con voce umana e volava fuori e dentro la grotta con rapidità siderale.
Ero certo che la fanciulla fosse là dentro. Sentivo l’eco delle sue risa, mi chiamava, voleva che entrassi. Sbirciai dentro ma era buio e quell’oscurità mi infuse un terrore intenso. Mi svegliai di soprassalto.
Quel sogno si ripeté svariate notti. Poi una sera, mentre passeggiavo sulla spiaggia ai piedi del castello, come ero solito, avvenne che mi spinsi più avanti del consueto. Voltai l’angolo di un’insenatura che nelle mie passeggiate non avevo mai doppiato e mi trovai dinanzi a una piccola grotta.
Entrai. Era bello, i riflessi argentini delle acque proiettavano figure incantevoli sulle volte di quella piccola cattedrale marina. Come ovvio non c’era alcuna fanciulla ad attendermi, ma l’acqua era limpida, pura, così trasparente che potevo vederci attraverso tutto il mio corpo, le mie gambe, le ginocchia, i piedi affondare in una polvere dorata.
Da quel giorno tornai più volte in quel posto. Nelle mie fantasie era una piccola cappella dove raccogliermi e pregare. Sedevo sulle rocce più basse, le acque lambivano le mie ginocchia e ascoltavo le loro fluttuanti carezze ordinarmi pensieri di devozione, di penitenza, ma soprattutto pensieri di riscatto che pian piano, giorno dopo giorno, giunsero a concretarsi in un solo, persistente, proposito: rischiare di evadere il confino per rimettermi sulle tracce della donna che col mio gesto avevo condannato ma che sentivo non poteva essere morta.
Una sera come tante scesi nella mia personale cappella, un poco più tardi del solito. Il crepuscolo già inargentava la volta della piccola cattedrale e le acque alle mie ginocchia trascoloravano dal color dell’oro in scintillanti distese opalescenti.
Ero in uno stato di totale contemplazione quando sentii la sua voce pronunciare il mio nome, cristallina, così come le pareti della mia chiesa. Aprii gli occhi e la vidi. La marea era salita, le acque mi lambivano i glutei. Non avevo mai visto quella donna, né in Venezia né nelle vicinanze del forte, ne ero certo, ma in quel frangente la sua presenza in quel luogo mi parve del tutto naturale.
Mi disse che non avrei dovuto temere quello che avrei visto, che non dovevo avere paura. Nel mentre affondò le mani nell’acqua fino all’altezza del pube, e dall’acqua emerse un oggetto, un vaso di cristallo ricolmo di perle. Lo riconobbi all’istante: era il vaso che il cardinale mi aveva offerto quella notte sciagurata e che io avevo rifiutato.
La fanciulla notò la mia meraviglia tinta di terrore, mi rassicurò: mi tese il vaso e disse che quello, quello soltanto sarebbe stato lo strumento del mio riscatto: disse che, se era davvero mia intenzione rischiare di lasciare l’isola, avrei dovuto custodirlo durante tutta la mia ricerca, che se anche avessi perduto una soltanto di quelle gemme non avrei mai più riacquistato la libertà del mio spirito.
Afferrai l’oggetto che mi tendeva e lo abbracciai. Stavo per chiedere: «Come, come posso ritrovarmi, liberarmi?» ma prima che potessi aprir bocca la fanciulla era già sparita senza lasciare traccia. Soltanto un’eco sentivo frangersi tra le rocce della caverna:
– Resisti, sopporta, capovolgi, – diceva, parole impenetrabili che nel loro dissolversi colmavano quel vuoto di una speranza per me ancora più oscura.
Ancora oggi, se ripenso a quella sera, non posso spiegare come quella giovane donna apparve, come fosse in possesso del vaso del cardinale, e soprattutto chi lei fosse. Quel vaso mi era stato offerto una seconda volta forse a monito, come memento del gesto che avevo compiuto e che mi aveva reso dannato? Non potevo saperlo, ma una cosa era certa: da quel momento in quel cristallo sarebbe stato tutto il mio mondo, perché da quello dipendeva la speranza della mia salvezza.
Non avevo la minima idea di come avrei potuto riconquistare una libertà che quella sfortunata notte mi ero tolto da solo mettendo quella maledetta firma, tuttavia preservare la salute di quell’oggetto era la condizione che mi era stata imposta affinché potessi lasciare l’isola e mettermi in viaggio per cercare la donna che, lo sentivo, era ancora viva, là da qualche parte oltre il mare. Quindi strinsi al mio petto quel vaso, e fu da quel giorno la miglior parte di me.
– E adesso a dormire! – sentiva Megara la zia gridare al piano di sotto. E allora si affrettava a richiudere il libro verde e a infilarlo lesta sotto il materasso, perché sapeva che zia Floria non amava vederla con quel coso polveroso in mano.
Così, seduta sul bordo di quel lettino che cigolava e ondeggiava come le gondole giù nei canali, tutte le sere Megara sfogliava il libro alla ricerca della fine della storia. Ma le ultime pagine erano state strappate.
Eppure, lo ricordava, negli anni in cui aveva vissuto a Cipro con suo padre aveva sentito più volte le donne dell’isola narrare della storia del giovane in confino nella rocca, una storia magica che ancora andava pellegrinando di bocca in bocca, da terra a terra, di mare in mare, da isola ad isola, sicché non era più possibile discernere, come spesso accade con tutte le cose orfane, quel che era cronaca da quel che era leggenda. La vicenda era diventata nel tempo un palinsesto tormentato, sempre più sbreccato, sul quale ognuno andava di propria mano ora ad aggiungere ora a grattar via frammenti, uno dopo l’altro, dapprima compromettendo, infine forse del tutto occultando, l’originaria sinopia. E anche Megara aveva infine conosciuto uno strato del palinsesto.
«Ma se una storia finisce senza una fine, non può essere davvero una storia», ruminava la ragazzina affondando nel sonno. E sognava delle spiagge di Cipro, dei sentieri di bouganville scarlatte, vie rosse battute da venti con voce di drago che menavano fin giù al porto, verso quel che restava dei mercati, verso l’oro della sera che ancora per lei odorava di spezie e di mare.
Specifiche
- Pagine: 224
- Anno Pubblicazione: 2020
- Formato: 14x21
- Isbn: 9788896988671
- Prezzo copertina: 16,00
- Prezzo Ebook: 2,90
- https://bit.ly/2FYWXa6