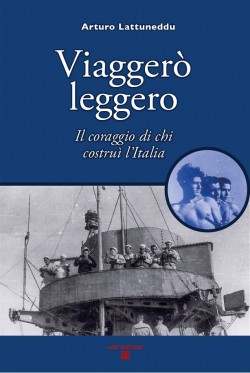Arturo Lattuneddu
Viaggerò leggero
DA HOMO A UOMO
Qualche settimana dopo la sua scomparsa mi giunse un manoscritto
che non arrivava a cento pagine.
Erano fogli di quella carta antica un po’ grossa, color giallo
sbiadito con sottili righe blu, sulla quale risaltava la sua
tipica scrittura con penna stilografica, inclinata e ornata da
grosse maiuscole come capoverso.
Non riuscivo a capacitarmi di ricevere posta proprio da lui
– mai successo prima – che scriveva soltanto per sé e quindi
un po’ smarrito mi rigiravo fra le mani una busta così sottile
da far malinconia.
Una rapida scorsa all’incartamento mi rivelò un intreccio di
fatti giovanili e di guerra dei quali si era dimenticato di parlare
e ne faceva ammenda nella lettera di accompagnamento.
Anche qui poche, stringate parole.
Aveva dedicato gli ultimi anni a mettere ordine nella trama
di una vita scapestrata e avventurosa. Alla sua età era un
privilegio anche solo parlarne senza amnesie e cali di lucidità
e conveniva che essere durato tanto si era rivelata una
faccenda complicata, dolorosa e formidabile al tempo stesso.
Qualcuno gli aveva suggerito di scrivere un’autobiografia e
l’idea gli era piaciuta. C’era abbastanza materiale per non
farne soltanto una questione personale: aveva vissuto più
epoche, era andato fuori di casa presto, attraversato una
guerra mondiale, viaggiato per mare e soprattutto osservato
con occhio attento e indagatore registrando fatti, uomini e
falsi dei.
Alla fine era prevalso il suo carattere schivo e non se ne era
fatto niente perché “… parlare di cose successe è un conto,
mettere insieme tante parole e scriverne è un altro paio di maniche…
”.
Però mi esortava a provarci in sua vece con un’amichevole
benedizione e la raccomandazione di riportare fedelmente
quello che mi aveva detto senza inventarmi nulla.
Allegava, a integrazione degli eventi già raccontati, una sorta
di relazione, un curriculum vitae ordinato come una linea
del tempo che “… forse servirà a qualcosa o a qualcuno …”.
Avevo tutto e accettare l’invito fu una decisione facile.
Avrei provato a scrivere la storia vera e paradigmatica di un
multiplo, un homo vulgaris, che diventa un singolo, un uomo
unico, attraverso scenografie di vita quotidiana, di amicizia,
di lotta e di amore in un tempo di morte.
Entrare nella sua parte è stato come muoversi alla ricerca
delle origini di un’altra Italia e di una particolare razza di italiani,
gente fiera, pulita, curiosa, purtroppo estinta da molti
anni.
ABBI CURA DI TE
Ciò che lo circonda da anni è la landa di una memoria sopita:
lui si è adattato, ma non esiste più nulla di quello che era un
tempo.
Quella stanza, l’ultima, proprio in fondo al corridoio e poi
a sinistra, la undici mi hanno detto, ma sulla porta ci sono
soltanto alcuni chiodi attorno al profilo più chiaro del numero
che non c’è più.
Sono nell’ala più vecchia dell’ospedale, quella che nel disegno
originale voluto da Mussolini era il sanatorio per i
tubercolotici infettanti; c’è odore di antisettico mischiato a
quello di un minestrone e il silenzio, innaturale.
Ora è il padiglione degli anziani, il cimitero degli elefanti.
Entro piano, nella penombra due letti con sagome indistinte
e immobili sotto le coperte; sembrano morti anche se i monitor
dicono il contrario. Un altro letto più lontano è vuoto,
aperto con le pieghe in squadro, perfette, ai suoi piedi una
persona su una sedia, leggermente piegata in avanti, un piede
irrequieto che sembra battere il tempo.
Mi blocco sulla soglia per mettere a fuoco l’insieme e mi
soffermo sull’uomo seduto. Solamente ora mi accorgo che
indossa le cuffiette ed evidentemente sta ascoltando musica.
Rimango un attimo interdetto e penso al sottoscritto o a
quel che ne potrebbe rimanere a novant’anni, perché credo
che questa sia all’incirca l’età del soggetto come dalla richiesta
avanzata per una consulenza.
L’immagine che mi si delinea è surreale, ma cerco comunque
di propormi avanzando nella camera verso di lui con la
mano tesa. Stacca prima un auricolare e odo un po’ di classica,
Mozart e il suo “Flauto Magico” mi sembra, poi l’altro
e spegne un iPod portatile.
Finalmente ho la sua attenzione, mi ripresento e aspetto. La
sua reazione si limita a un cenno rispettoso del capo e a una
vigorosa stretta di mano, in piedi dinanzi a me che sembro
perfino più basso e ingobbito di lui.
Mi confida – non sono io a guidare la conversazione – che
conosce la sua situazione, ha valutato i pro e i contro e accetta
incondizionatamente magari con la promessa, neanche
troppo scherzosa, di un paio d’anni di bonus vitae.
Conclude chiedendomi chi eseguirà l’intervento.
Alla risposta “Io” abbozza appena e se ne esce spontaneo con
un bel “Ma lei opera ancora!?! ”.
Considero brevemente che quest’ultima riflessione non
manca di ragionevolezza e rilancio “Anche lei non è più un
giovane virgulto e nonostante questo non se la passa poi così
male! ” ammiccando girato verso i compagni di camera.
La sua domanda innocente mi ha scosso e ho come un
flashback.
Molti anni prima, giovane chirurgo appena specializzato,
agguerrito e con tutte le conoscenze più moderne, mi ero
imbattuto nel paziente “perfetto” per incominciare a muo-
vere le mani senza fare danni: anziano ma non decrepito,
nessun parente stretto, magro come un chiodo e soprattutto
poco malato a parte il tumore.
Avevo spiegato con dovizia di particolari, nominato tecniche
e cure avanzate ben padroneggiate, citato statistiche e studi
internazionali alcuni recentissimi. In breve, ero stato l’incarnazione
delle linee guida aziendali relative al “Consenso
informato”, anzi dovrei dire che l’aggettivo giusto sarebbe
stato “esagerato” perché al momento del dunque, della prenotazione
con firme e controfirme, il tipo aveva rinunciato
senza troppi giri di parole: “Mi sembra troppo giovane per
saper fare tutte le cose che mi ha elencato”.
Il rifiuto di allora mi aveva ferito molto più delle perplessità
sollevate adesso che potevo accettare e confutare facilmente
con la forza di numeri incontestabili.
Non volevo promuovermi mentre invece cominciava a incuriosirmi
l’uomo che avrei conosciuto meglio nei mesi successivi.
Andavo di fretta perché credevo mancasse il tempo considerata
l’età e la malattia, ma mi sbagliavo: erano cominciati
i pomeriggi col maestro Picchi e, prima ancora, il sergente
elettricista Picchi e le sue vicende in parte a cavallo delle due
guerre, non tutte menzionate nei libri, ma impresse a tinte
vivide nella sua mente. Avrei visto attraverso i suoi occhi
fatti e persone che nessuno ricordava più o forse aveva mai
conosciuto.
Ero di strada perché casa sua sorgeva a circa metà della via
che percorrevo ogni giorno andando e tornando dal lavoro.
Mi spostavo in bicicletta e quindi era facile fare quella piccola
deviazione, guardare se la finestra aveva gli scuri aperti
e presentarmi dopo una scampanellata.
Non facevo in tempo ad aprire il portone che immancabilmente
mi veniva incontro per le scale ringraziandomi per la
“graditissima” visita. A seconda della stagione si scusava del
troppo caldo o del troppo freddo come se lui potesse regolare
la temperatura a piacimento e mi faceva accomodare in
salotto preparandomi alla confusione che avrei trovato.
Non facevo domande, non prendevo appunti, non interrompevo
i silenzi e il flusso spontaneo delle parole, a volte
persino sonnecchiavo cullato dalla sua voce, ben immobilizzato
dal suo vecchio divano a molle che stava appoggiato
alla parete quasi nascosta da quadri di ex voto di marina e
fotografie, nel suo piccolo appartamento del quartiere detto
“del fascio”.
Picchi “la rondine” volava via a novembre per le Canarie
con la compagna più giovane di vent’anni e tornava a marzo
inoltrato lasciandomi nelle nebbie e al freddo, talvolta in
piedi come un allocco davanti alla porta a Natale con una
bottiglia e un panettone in mano, a suonare invano il campanello,
dimentico del solito viaggio migratorio.
Le rondini e la loro straordinaria vocazione a ricamare il cielo
dei due emisferi, un giorno qui e domani là, mai stanche di
librarsi e incapaci di scendere a terra, proprio come Picchi.
A volte ci si imbatte in una storia solo apparentemente comune
che aiuta a riscoprire, in un contesto più che ordinario,
protagonisti eccezionali o persone stupende, talmente
improbabili e singolari da sembrare finti, a dimostrazione che
nella vita ognuno può essere personaggio e distinguersi malgrado
tutto. In fondo – e c’è da crederci – il destino e la fortuna
sono sì ciechi, ma anche giusti e indulgenti e non sempre
all’ascesa segue una rovinosa discesa nonostante che per alcuni
gli esami e le prove non finiscano mai.
E questo porta alla considerazione successiva, quella sulla vita
assimilata a un teatro coi suoi teatranti: nell’arco di un’esistenza
ciascuno di noi deve recitare più ruoli, tutti diversi e non
sempre graditi, talvolta nemmeno di libera scelta purtroppo.
Si finisce così con l’invecchiare in molti modi, taluni veramente
pessimi, malati e rancorosi, altri senza neanche saperlo,
svagati e troppo allegri per via della testa e della ragione
perdute, pochi fortunati godendo appieno del presente e del
domani, senza nominarlo mai per scaramanzia.
Picchi Giuseppe faceva parte di quest’ultimo sparuto gruppo.
Per lui l’ultimo atto, ovvero la pensione, era stato un concetto
astratto, più un ritiro di approfondimento spirituale
che non una smobilitazione. Finalmente avrebbe potuto
dedicarsi a programmi di ricerca storica liberati da scadenze
improcrastinabili o da ordini superiori, permettendosi il
lusso di una lettura tranquilla e ponderata, soprattutto quella
notturna quando gli altri dormono e gli scocciatori non
possono interromperla.
Libri vecchi e nuovi, letti e riletti, annusati e sfiorati come
un fiore o una bella donna, prezioso rifugio dalle brutture
del quotidiano e talvolta singolare salvadanaio di piccole fortune
in banconote.
Aveva infatti come tutti un conto bancario, ma non disdegnava
nemmeno un’alternativa al classico materasso e fra le
pagine di questo o quel libro finivano disseminate carte da
cinquanta o cento euro, un po’ come fa lo scoiattolo con le
ghiande nascoste nei buchi di alberi diversi.
E proprio come avviene in natura anche nelle sue quotidiane
scorribande letterarie non tutti i ricoveri venivano ricordati,
ma quelli ritrovati suscitavano sempre un genuino stupore.
Poco male se poi i conti non tornavano mai perché come
dice un tale, non ricordo più chi fosse:
“E’ un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude
con profitto”.
Mi vedo allo specchio e guardo avanti mentre
gli altri mi vedono e guardano indietro.
(Julius Erving)
Specifiche
- Pagine: 244
- Anno Pubblicazione: 2020
- Formato: 12,2x18,8
- Isbn: 88-6086-182-5
- Prezzo copertina: 14,00