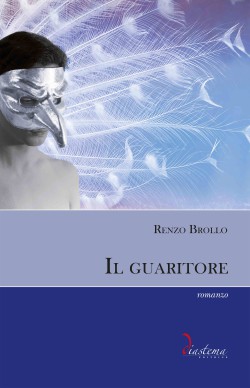Renzo Brollo
Il guaritore
È una storia liberamente ispirata (e dedicata) alla vita di uno dei più famosi cantanti castrati del Settecento: Carlo Broschi detto Farinelli la cui voce, bianca e affascinante, incantò il mondo delle corti e del clero per lunghi anni. Questi cantanti ebbero una genesi dolorosa e terribile che li portò a condurre una vita fuori dall'ordinario. Partendo dalla vicenda di Farinelli, che alla corte dei reali di Spagna guarì il re malato di depressione cantandogli ogni notte le stesse quattro arie, l'autore ha immaginato un piccolo Carlo moderno, che a sua volta diventerà guaritore e idolo pop, felice e infelice allo stesso tempo, così come dovevano essere molti castrati costretti a un dono che non scelsero mai.Carlo diventa una creatura nuova, angelica e mostruosa. Ma al suo corpo, dentro la sua testa, manca ancora qualche cosa. Qualcosa che si era solo nascosto per non morire.
Carlo è il protagonista del romanzo di Renzo Brollo ispirato alla figura di Carlo Broschi Farinelli, l’evirato cantore del Settecento che è stato storia e mito, delirio di successo e angosciante solitudine. E prima di tutto violenza, subìta.
Brollo, ed è intuizione originale e possibile, ricrea Farinelli oggi. Quel Carlo diventa il suo Carlo, nostro contemporaneo. L’indefinibile registro vocale degli angeli di Dio, la loro indistinzione sessuale, li rendeva dei seduttivi transgender, capaci di condurre il pubblico al delirio.
Abitiamo un’epoca avida di ambiguità ed esperienze, lungo il crinale, così arduo da distinguere, tra virtuale, reale, realtà virtuale. Il tempo di Farinelli è finito, è iniziato quello di un altro Carlo. Brollo lo narra. (Sandro Cappelletto)
Primo capitoloPreludio
La mano nera
Tutto ciò che non si piange è già perduto.
Inseguo il tuo cantare
dall’altra parte del muro del labirinto
e mi pare che già ci sia più tempo
e che la cattiva alba ritardi il suo arrivo.
Una mano nera, invisibile nel buio assoluto, si muoveva fendendo l’aria caldissima della cameretta. Le dita si aggrappavano ai capelli e il palmo lo colpiva sulle guance, facendolo cadere a terra. Più si nascondeva, più la mano nera lo cercava e lo raggiungeva per colpirlo ancora e con sempre maggior violenza. Non c’erano voci attorno, non c’era lo schiocco dello schiaffo, non c’era suono in quei colpi. Non sono veri, pensava ogni volta. Eppure le gote infiammate le poteva sentire, le poteva toccare ed erano vere e il dolore era autentico, come autentiche erano le lacrime che cadevano sopra le lenzuola, sebbene cercasse in tutti i modi di trattenerle. La mano nera tornava ogni volta che lui veniva sorpreso a cantare.
Primo movimento
La voce nascosta
La musica era nell’aria e non smetteva mai. Conquistava tutte le stanze e l’ultimo disco inciso da suo padre Luigi non veniva mai tolto dallo stereo, se non durante le poche ore di sonno dei suoi genitori. Il rock neomelodico, monotono e noioso, delle canzoncine cominciava all’alba, raggiungeva anche il più piccolo angolo polveroso della più remota stanza della casa e lì rimaneva fino a tarda notte, ma nessuno osava protestare. Non suo fratello maggiore Stefano, non la madre Eleonora, che da tanto ormai pareva non accorgersene e sentirla più. Se ne stava quasi sempre chiusa dentro la camera e stesa a letto, in cerca di un riposo che Carlo immaginava non riuscisse più a ritrovare, forse per colpa di qualche strana malattia che i grandi gli tenevano nascosta.
Nella luce calda di quel pomeriggio estivo, Carlo vagava scalzo per le stanze vuote nel tentativo di resistere alla voglia di spalancare la bocca e cantare, ma trattenersi era impossibile. La musica e il cantato, sempre sul filo della stonatura, sembravano incitarlo a cantare a sua volta, come se cercassero il confronto e la sfida. Per distrarsi, si sforzò di pensare al rumore metallico delle forbici che suo padre stava usando per potare la siepe e allo sfrigolio del fuoco che il fratello Stefano aveva acceso per bruciare le erbacce ma, come ogni volta, la tentazione si trasformò in desiderio e il desiderio in bisogno impellente e, senza nemmeno rendersene conto, già stava schiudendo le labbra per sussurrare i primi versi. Dal principio la voce uscì flebile, poi sempre più sicura, leggera e cristallina. Sapeva che, se suo padre lo avesse scoperto, avrebbe dovuto subire una severa e dolorosa punizione, ma questo non gli impedì di continuare. Mentre rincorreva la melodia, chiuse gli occhi e seguì a memoria il profilo dei muri. La sua voce si accostò e si sovrappose a quella registrata del padre, la rinvigorì fino a sentirla viva e sua dentro al palato.
Quando arrivò davanti alla porta chiusa della camera dei genitori, smise di cantare e appoggiò l’orecchio al legno laccato dello stipite. La voce registrata si fece di nuovo sguaiata e la musica tornò in sospensione nell’aria, roteando sul soffitto come se si fosse offesa per quell’abbandono. All’improvviso, sua madre chiamò dolcemente il suo nome, strappandogli un sorriso. Riaprì gli occhi ed entrò nella camera cercandola nel buio.
– Vieni Carlo. Siedi qui accanto a me.
L’aria calda e sigillata dalle persiane chiuse era soffocante. A tentoni si avvicinò al letto, immaginando il profilo della madre stesa, fino a che i suoi occhi non si furono abituati e non riuscì a distinguerla nel buio.
– Carletto, sai che giorno è domani?
– È il tuo compleanno!
Intravide i denti di sua madre brillare flebili dentro a un sorriso che sembrava già stanco.
– È proprio così e domani tu mi accompagnerai in un posto speciale. Voglio portarti a fare un giro. Solo io e te, vuoi?
– Mi piacerebbe tanto, ma proprio tanto, mamma!
– Anche io sono contenta. Ora vai, lasciami riposare.
Sul viso avvertì una leggera e profumata onda di calore, quando il corpo di sua madre scivolò di nuovo dentro alle lenzuola con un leggero fruscio.
Uscì dalla camera felice per quella notizia inattesa. Da tanto non facevano più lunghe passeggiate assieme e non condividevano momenti che dovevano restare segreti a suo padre e suo fratello. Era eccitato. La canzone che aveva abbandonato per stare con la madre tornò a volteggiare sopra la sua testa. Di nuovo chiuse gli occhi, riprese la melodia e la strofa della canzone che ora si stava chiudendo per riattaccare un ritornello sempliciotto e buffo. Afferrò la nota, le diede forza e la costrinse a restare intonata. Si spostò verso la sua camera e solo allora percepì che il rumore delle forbici era sparito. Finì addosso al corpo del padre, che a gambe larghe occupava l’intero corridoio.
– Quante volte ti ho detto di non cantare le mie canzoni. Eh, quante maledette volte te l’ho già detto?
Il bambino aprì gli occhi e guardò la mano calare sulla sua faccia.
***
Venne la sera e poi la notte. Lo stereo fu spento e la musica da balera scomparve dalle stanze, lasciando nella casa un silenzio denso di pensieri, che frullavano sul soffitto come pipistrelli spaventati. Quelli ambiziosi di Luigi Matteri per le sue canzoni e quelli speranzosi del figlio Stefano si intrecciavano a vicenda, rincorrendosi e scontrandosi simili tra loro come lo erano padre e figlio, mentre i pensieri del piccolo Carlo erano tutti rivolti alla madre Eleonora, che ora sentiva camminare per le stanze vuote e buie. Pensando alla sorpresa che le aveva preparato per il suo compleanno, sorrise e la federa del cuscino gli pizzicò la guancia arrossata per lo schiaffo ricevuto. Il sonno lo portò via con sé, mentre ancora cercava di ripetere a memoria i versi della canzone che aveva imparato a memoria per regalarla a sua madre.
Quando si svegliò, vide la faccia di Stefano appiccicata alla sua. Sentì subito l’odore forte e acre di naso mal pulito, di orecchie non lavate, di sudore vecchio e di fumo di sterpi bruciati. Stefano aveva piccole lentiggini sulle guance e occhi verdi e grigi che si accendevano di una luce spietata quando li rivolgeva ai suoi. Ma era suo fratello maggiore, secondo suo padre l’esempio da imitare, e Carlo gli voleva bene. Nonostante tutto.
– Buongiorno nanerottolo, ti sei svegliato finalmente.
Carlo stette in silenzio, ancora intontito, a osservare quegli occhi freddi puntati addosso ai suoi. Erano gli specchi di quelli più vecchi del padre, marchio di famiglia per loro due che ne andavano fieri. Aveva quindici anni e già due provini alle spalle andati male. Carlo sentiva la sua voce stridere nell’aria come unghie sulla lavagna. Era uno sbaglio terribile, da quando le corde vocali iniziavano a vibrare fino alla morte dell’ultima nota nata male.
– Lo sai che sono già le nove di mattina? Lo sai che la mamma è già uscita perché tu non ti svegliavi mai?
Carlo schizzò fuori dal letto, prese i vestiti e si chiuse in bagno. Non poteva aver tradito sua madre dormendo così a lungo. E lei, perché non lo aveva chiamato? Perché era uscita senza di lui per andare nel posto speciale? E ora, l’avrebbe ritrovata?
Mentre fuori suo fratello picchiava alla porta ridendo e facendo finta di guaire come un cane spaventato, si guardò allo specchio. L’ombra della mano di suo padre era ancora ben visibile sulla guancia e se la mano nera era il suo incubo ricorrente, quei segni rosso scuro stavano lì a ricordagli che le regole del padre erano state di nuovo infrante. Si lavò la faccia e schizzò fuori dal bagno, inseguito dalle risate sguaiate di suo fratello Stefano. Scese per la strada sterrata di corsa. Faceva già molto caldo, il ronzio delle mosche e il canto delle cicale correvano con lui verso il fiume che stava poco più in basso, assicurato al suo alveo con briglie e alte sponde di cemento. Cadde, mancando un piccolo dislivello, e finì dentro un cespuglio di rovi. Ne uscì a fatica. Si mise a piagnucolare ma ricominciò a correre e prese il sentiero che seguiva la corrente del fiume. Arrivò al ponte e si fermò a respirare. C’era una luce così forte che i contorni delle cose restavano sbiaditi e i colori impastati. Nell’ora più luminosa, la natura non aveva ombre. Il ponte che attraversava il fiume aveva quattro grossi piloni tondi di cemento armato, che permettevano alla strada di attraversarlo. I due centrali affondavano nell’acqua ricca di schiuma mentre i due laterali, più tozzi e impastati di fango, penetravano nel terreno per due terzi. Dietro uno di essi, vide spuntare i piedi nudi di sua madre. Le si gettò in braccio ridendo e piangendo di gioia.
– Sei arrivato finalmente! Ti stavo aspettando.
Carlo nascose la faccia nell’incavo dei seni della donna, in cerca del calore e dell’odore della sua pelle.
– Perché non mi hai svegliato? Perché sei uscita senza di me?
– Ma siamo qui adesso. Questo è quello che conta, no? E poi dormivi così bene che mi dispiaceva farlo. Sapevo che saresti arrivato, prima o poi. Tuo fratello ti ha maltrattato?
Carlo scrollò le spalle, fingendo coraggio.
– Solo un pochino, ma non m’importa.
– Bravo il mio soldatino. Ma non devi dirmi niente?
Le saltò al collo, tempestandola di baci.
– Buon compleanno, mamma!
La sentì ridere con quella voce fresca che dalla sua bocca usciva sempre più di rado. Ora, invece, superava il rumore del fiume, si innalzava fino alle volte metalliche e tornava a lui in una eco miracolosa. La strinse ancora più forte. Sapeva della sua debolezza, pur non conoscendone il significato e nemmeno le conseguenze. Aveva spiato suo padre alzare la voce anche con lei, incolpandola del suo mancato successo. E anche don Mauro, che ogni tanto le faceva visita, non aveva mai avuto molte parole buone per lei, come se, più che una malattia, la sua fosse un’ottusa presa di posizione contro il mondo intero. Carlo aveva otto anni, ma capiva molto bene che suo padre e suo fratello non li amavano, almeno non quanto lui e sua madre amavano loro.
La mano di sua madre indugiò a lungo sopra la guancia di Carlo, sovrapponendosi alla traccia scura del livido. Bruciava e doleva ancora, ma non gli importava più. Non ora che si erano ritrovati, non ora che avevano ricreato la magia. Si sciolse dall’abbraccio e si mise ritto davanti a lei, le braccia rilassate lungo il busto e i piedi uniti. Chiuse gli occhi, cercò nel palato la nota giusta e poi cominciò a cantare.
Oi Ricciulina
oi marranchina
oi signurina,
fai la li la…
Fa’ li la li la…
Tu m’he traduto
e m’he feruto
l’aggio saputo,
fai la li la…
Fa’ li la li la…
Tu me vuò muorto
ma io me ne accuorto
ma hai gran tuorto,
fai la li la…
Fa’ li la li la…
Stella diana
sì ruffiana
fai la puttana,
fai la li la
Fa’ li la li la…[1]
La voce tremò, anziché sostenersi decisa sul finale che avrebbe dovuto restare alto e imperioso per celebrare l’accordo maggiore liberatorio. Attraverso tutto il canto, si era imposto di non pensare a lei, cercando di articolare la melodia come l’acqua del fiume poco distante, fluente e portatrice di una storia. Ma non ce l’aveva fatta. Aveva detto puttana davanti a sua madre e per giunta cantando una canzone dedicata a lei. L’emozione e la vergogna avevano vinto la battaglia col suo respiro, che si era spezzato. Ora che la voce si era spenta, non osava aprire gli occhi per paura che a lei non fosse piaciuta.
– Ricciulina, – bisbigliò sua madre – dove l’hai trovata?
– Non posso dirtelo, mamma. È un segreto.
– Perché non mi guardi?
– Perché non so.
– Cosa non sai, Carlo?
– Se ti è piaciuta, perché non l’ho cantata come dovevo.
Si sentì sollevare dalle braccia di sua madre e di nuovo portare dentro la nicchia, chiuso nel baccello segreto. Capì che aveva superato la prova e che il regalo era già amato.
– Carletto, Carletto mio, ma come fai? Mi dici come fai a cantare così, tu che sei così piccolo?
Scosse la testa e sorrise, imbarazzato. Lui non sapeva. Non sapeva come, ma accadeva ed era inevitabile e meraviglioso e doloroso anche. Quando una canzone lo colpiva, lo attirava a sé, come se il suo corpo e la sua testa venissero trascinati verso la musica da una corda invisibile. E poi la sua bocca si apriva da sola e dalla gola uscivano note e parole che non sempre riusciva a comprendere. In tutto ciò non c’era spavento, ma estasi, anche se non avrebbe saputo definirla così. Sapeva però che quel canto consolava sua madre, così come consolava lui e questo gli bastava e questo lui voleva.
– È stato bellissimo, bambino mio, bellissimo. Non potevi farmi regalo più bello. Ora però tocca a me farti una sorpresa, – disse sua madre sollevandosi e prendendolo per mano. – Ma dobbiamo sbrigarci o arriveremo tardi!
Madre e figlio uscirono insieme alla luce del sole, spezzando l’incantesimo che li aveva nascosti lì. I colori tornarono a sbiadire, i profili si impastarono di nuovo e le ombre scomparvero da sotto le cose.
Trascinato da sua madre, Carlo correva verso il paese. Era impaziente di conoscere la loro meta, che lei aveva voluto tenere nascosta e che ora stava per diventare luogo, tempo e spazio reali.
[1] Anonimo, Oi, Ricciulina (villanella del XVI secolo).
Specifiche
- Pagine: 384
- Anno Pubblicazione: 2019
- Formato: 14x21
- Isbn: 9788896988626
- Prezzo copertina: 16,00
- Prezzo Ebook: 2,90
- https://bit.ly/32wbSQu